2015: Siamo nell'anno della Luce!

Alla fine dello scorso anno 2013, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla luce. In altre occasioni, l’interesse della comunità internazionale era stato indirizzato verso l’Anno dell’Astronomia (2009), l’Anno della Biodiversità (2010), l’Anno dell’Acqua (2013), ecc. Quattro gli ambiti ufficiali entro i quali convogliare le manifestazioni: 1. La scienza della luce; 2. La tecnologia della luce; 3. La luce in natura; 4. La luce e la cultura. In Italia le iniziative per l’Anno della Luce saranno coordinate dalla Società Italiana di Fisica (SIF), mentre per i collegamenti con la ricerca astronomica ed astrofisica faranno da referenti l’International Astronomical Union (IAU) a livello internazionale e, in Italia, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Società Astronomica Italiana (SAIt). In quest’ultimo ambito si sottolineerà l’importanza della “Luce Cosmica”, cioè la ricezione e lo studio dell’energia proveniente dagli oggetti celesti, un aspetto determinante per il progresso delle nostre conoscenze scientifiche. Se in passato l’opinione pubblica era stata già sensibilizzata a ridurre lo spreco di energia e a diminuire l’inquinamento luminoso — quest’ultimo particolarmente importante per la ricerca astronomica e astrofisica da terra, ma anche per tutti coloro che rivolgono lo sguardo al cielo stellato — l’iniziativa del 2015 è di ben più ampio respiro. Non si tratta solo di difendere o ben amministrare qualcosa, ma di comprenderne in maggiore profondità le implicazioni e le virtualità, sia scientifiche che culturali.
Dell’assoluta importanza dell’acqua siamo tutti persuasi, così come siamo consapevoli di quanto determinante sia la qualità dell’aria per la nostra vita. Riflettiamo forse un po’ meno sul ruolo della luce, trattandosi di una realtà che ci accompagna e ci avvolge, in modo più discreto dell’aria e dell’acqua, ma non per questo meno essenziale. L’acqua è una semplice molecola di soli 3 atomi, due di idrogeno e uno di ossigeno, mentre l’aria è un miscuglio di diversi elementi e composti chimici in diverse proporzioni; la luce, invece, è da esse qualitativamente diversa, perché ci si presenta come energia. Riserviamo infatti il nome di “luce” a quei valori dell’energia elettromagnetica, fra circa 3.800 e 7.500 Angstrom (380 – 750 nm), ai quali il nostro occhio è sensibile, e che per questo motivo chiamiamo “luce visibile”. In tal modo, la differenziamo da quelle altre forme di energia elettromagnetica che non vediamo ma i cui effetti avvertiamo, come ad esempio i raggi X o le onde radio. Già alla fine dell’Ottocento siamo stati in grado di definire, con James Clerk Maxwell, le elegantissime equazioni che descrivono la propagazione della luce e delle onde elettromagnetiche in genere; mentre all’inizio del Novecento abbiamo scoperto, con Max Planck, che l’energia si propaga mediante “quanti”, ovvero quantità discrete e non secondo valori continui, che nel caso della luce visibile chiamiamo fotoni. Albert Einstein metterà a punto poi un’altra equazione, anch’essa assai elegante, capace di descrivere le reciproche trasformazioni fra materia ed energia. Grazie a questi tre scienziati, nello spazio di pochi decenni, fra fine ottocento e primi del Novecento, la nostra conoscenza sulla natura della luce ha compiuto un enorme balzo in avanti.
Assai prima della contemporanea “fisica della luce”, il ricco simbolismo della luce era stato già catturato da molteplici manifestazioni della cultura umana, dalla mitologia all’architettura, dalla poesia alla religione, dando origine alle più svariate riflessioni, filosofiche, artistiche e teologiche, ancor prima che scientifiche. In effetti, è difficile trovare nella storia del pensiero una realtà così gravida di significati e di allegorie. Opportuna, pertanto, la decisione delle Nazioni Unite di riservare uno dei quattro ambiti tematici dell’Anno della Luce proprio a “la Luce e la cultura umana”. Ci proponiamo di riprendere anche noi questo suggerimento attraverso una serie di “Speciali di Home Page” che i siti disf.org e inters.org pubblicheranno nei prossimi mesi. Come di consueto, privilegeremo gli aspetti culturali e interdisciplinari, senza disattendere però quelli scientifici. I documenti e gli approfondimenti che proporremo saranno necessariamente limitati, se confrontati con le molteplici dimensioni che un tema come questo è in grado di suscitare: desideriamo solo stimolare l’interesse dei nostri lettori, dando spazio ad argomenti meno noti al grande pubblico ma ugualmente significativi. Esplorare le dimensioni culturali, scientifiche ed umanistiche della luce è assai attraente e, per certi versi, entusiasmante. È proprio parte di questo entusiasmo e di queste scoperte ciò che desideriamo trasmettere ai nostri visitatori. Siamo sorpresi, ad esempio, quando costatiamo che un oggetto esteticamente così evocativo come l’arcobaleno, retto da una fisica non banale, sia stato anche oggetto di studio da parte dei primi “ricercatori sperimentali” delle università anglosassoni del medioevo, come furono Roberto di Grossatesta e Ruggero Bacone; o quando scopriamo che esso viene più volte presentato dalla Bibbia come segno di alleanza fra Dio e l’uomo. Ci si può ugualmente sorprendere al conoscere che le convinzioni religiose di uno scienziato come Maxwell abbiano influito sul suo modo di giungere alle note equazioni delle onde luminose, come sostenuto dal filosofo e storico della scienza Thomas Torrance.
Il legame fra luce e pensiero religioso è a tutti evidente. Non è un caso che chi apre la Bibbia, testo sacro alla tradizione ebraico-cristiana, legga nella sua prima pagina una solenne dichiarazione sulla luce. Secondo la narrazione della Genesi della creazione, le prime parole che Dio pronuncia in prima persona sono: «E Dio disse: Sia la luce» (Gen 1,2). Azione altamente evocativa che, seguendo una linea di riflessione neoplatonica, diede origine nel medioevo ad una vera e propria “metafisica della luce”. Con questa espressione si indicava una concezione dell’essere e del creato in cui la luce “trasportava” l’azione creatrice di Dio, attribuendo alla luce quanto noi oggi forse diremmo a proposito dell’energia. Sarebbe superfluo attardarsi qui ad elencare l’importanza che la luce assume nella sacra Scrittura (tema al quale saranno dedicati altri specifici contributi). È comunque evidente che il linguaggio biblico sulla luce presenta una gran quantità di metafore e allegorie, che puntano verso qualcosa di più che una semplice immagine. Luce è sinonimo di verità e di vita. Il Verbo incarnato è indicato come “la luce che viene nel mondo” (cfr. Gv 1,9; Gv 3,19) e Gesù di Nazaret dice di sé: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12; cfr. Gv 12,35). Chiunque fa il male, odia la luce; chi compie il bene indossa le “armi della luce”. Il salmista proclama che «in Te è la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce» (Sal 36,10). Per il libro dei Proverbi, «la strada dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio» (Prv 4,18). In modo davvero radicale Giovanni, ancor prima di affermare che “Dio è amore”, nella sua prima Lettera non teme di dichiarare che «Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna» (1Gv 1,5). In modo più generale, antropologicamente fondato, la luce entra a far parte del linguaggio religioso di tutti i popoli come simbolo di Dio, della sua trascendenza, della sua presenza pervasiva. Ne diviene un attributo. Ed è al tempo stesso simbolo e sinonimo della verità e del bene: la menzogna e il male sono assenza di luce, perché il buio favorisce le opere malvagie e la possibilità di occultare qualcosa. Non sorprende allora che, in modo derivato, il sole, fonte principale della nostra luce, sia stato per vari millenni oggetto di culto e di narrazioni mitologiche. E non sorprende che le grandi cattedrali del cristianesimo, specie in epoca medievale, ma con una tradizione che anche oggi rivive nella Sagrada Familia di Barcellona, basassero buona parte della loro architettura sulla dinamica della luce naturale o impiegassero il sole per la lettura del tempo e del calendario su imponenti ed artistiche meridiane.
 Esiste quasi un parallelo fra la centralità della luce nel linguaggio religioso e la centralità che essa assume nel quadro scientifico-naturale. L’uomo ha bisogno di Dio come, sul piano scientifico, la vita e l’uomo hanno bisogno di luce. Luce vuol dire energia. Delle quattro forme di energia che l’uomo conosce, quella elettromagnetica è più facilmente maneggiata e impiegata; se l’uomo sfrutta altre forme di energia, come ad esempio quella gravitazionale o quella nucleare, è per ottenere ancora energia elettromagnetica, di cui la luce visibile costituisce la parte a noi fisiologicamente più vicina. Nel sole, la grande efficienza dell’energia nucleare che si sprigiona nel suo nucleo, analogamente a quanto accade nelle altre stelle, giunge a noi ancora sotto forma di energia elettromagnetica, di calore e di luce. Senza luce solare non vi sarebbe fotosintesi clorofilliana, non vi sarebbe vita, senza il calore del sole non vi sarebbero processi biochimici, la terra sarebbe una distesa di roccia e di ghiaccio. La qualità della vita sulla terra dipende ormai, in modo determinante, dalla nostra capacità di ottenere energia e luce a basso costo, di poterla distribuire senza troppe perdite. Per questo motivo si è dato giustamente rilievo al premio Nobel per la fisica del 2014, conferito a tre ricercatori giapponesi, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura, meritevoli di aver scoperto i LED a luce blu, capaci di produrre energia che viene quasi interamente convertita in luce e non dispersa in calore. Circa un quarto dell’energia che produciamo sulla terra viene convertita in energia elettrica disponibile all’illuminazione e ciò fa subito capire quanto anche la luce che non proviene direttamente dal sole sia per noi ugualmente necessaria.
Esiste quasi un parallelo fra la centralità della luce nel linguaggio religioso e la centralità che essa assume nel quadro scientifico-naturale. L’uomo ha bisogno di Dio come, sul piano scientifico, la vita e l’uomo hanno bisogno di luce. Luce vuol dire energia. Delle quattro forme di energia che l’uomo conosce, quella elettromagnetica è più facilmente maneggiata e impiegata; se l’uomo sfrutta altre forme di energia, come ad esempio quella gravitazionale o quella nucleare, è per ottenere ancora energia elettromagnetica, di cui la luce visibile costituisce la parte a noi fisiologicamente più vicina. Nel sole, la grande efficienza dell’energia nucleare che si sprigiona nel suo nucleo, analogamente a quanto accade nelle altre stelle, giunge a noi ancora sotto forma di energia elettromagnetica, di calore e di luce. Senza luce solare non vi sarebbe fotosintesi clorofilliana, non vi sarebbe vita, senza il calore del sole non vi sarebbero processi biochimici, la terra sarebbe una distesa di roccia e di ghiaccio. La qualità della vita sulla terra dipende ormai, in modo determinante, dalla nostra capacità di ottenere energia e luce a basso costo, di poterla distribuire senza troppe perdite. Per questo motivo si è dato giustamente rilievo al premio Nobel per la fisica del 2014, conferito a tre ricercatori giapponesi, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura, meritevoli di aver scoperto i LED a luce blu, capaci di produrre energia che viene quasi interamente convertita in luce e non dispersa in calore. Circa un quarto dell’energia che produciamo sulla terra viene convertita in energia elettrica disponibile all’illuminazione e ciò fa subito capire quanto anche la luce che non proviene direttamente dal sole sia per noi ugualmente necessaria.
Grazie alla luce entriamo in relazione con gli altri, comunichiamo, trasportiamo informazione. Grazie alla luce il display dei nostri devices, dallo smartphone allo schermo del computer, dai monitor degli aeroporti ai semplici orologi digitali, ci offre in modo rapido ed essenziale le notizie e i messaggi necessari per prendere decisioni, capire cosa accade attorno a noi, vivere insieme agli altri e per gli altri. I laser collimano entro un angolo piccolissimo un fascio di luce concentrata consentendoci di riparare i nostri tessuti biologici, di costruire micromeccanismi, ma anche di stampare su carta, in modo chiaro e rapido, i nostri documenti. Siamo oggi capaci di “catturare” la luce con i milioni di colori che essa può esprimere, digitalizzarla e così trasportarla e riprodurla a nostro piacimento. Dalla scoperta del fuoco fino ai LED contemporanei, il modo di produrre la luce condiziona la nostra vita sociale e il nostro lavoro, i nostri legami familiari e il nostro riposo.
Non meno considerevoli sono i grattacapi che la luce ha causato alla filosofia della natura e della scienza. La sua velocità nel vuoto rappresenta, nel quadro delle teorie della relatività ristretta e generale, la velocità massima alla quale si può propagare un’informazione e, pertanto, anche la velocità massima alla quale si potrà mai fisicamente viaggiare. Questo limite ci pone di fronte all’impossibilità di renderci fisicamente presenti su mondi lontani, in galassie diverse dalla nostra o in stelle lontane anche poche centinaia di anni-luce dal nostro sole, limitando solo alle trasmissioni via radio la possibilità di comunicare con eventuali altri abitanti intelligenti del nostro universo. Dunque, potremmo solo eventualmente ricevere segnali, ma non dialogare con loro… a meno di non essere disposti ad attendere centinai o migliaia di anni fra le nostre domande e le loro risposte! La natura insieme corpuscolare e ondulatoria dell’energia ci obbliga ad approfondire la nostra conoscenza della luce, cercando paradigmi esplicativi sempre più soddisfacenti per rappresentarne il comportamento. Ci si chiede, infine, se la simmetria delle equazioni di Maxwell richieda o meno l’esistenza dei monopoli magnetici, che l’esperienza sembrerebbe escludere.
La luce si alterna però al buio, il giorno alla notte. L’Anno della Luce sarà anche un’occasione per farci apprezzare la debole luce che proviene da stelle diverse dal nostro sole, da galassie esterne alla nostra, da sorgenti di energia lontane il cui studio accurato è determinante per comprendere il nostro posto nel cosmo. Osservare altre fonti di luce è importante per capire sempre meglio la nostra, il sole, il suo futuro e il destino della vita che è fiorita su una dei pianeti che gli orbita intorno. I costi altissimi ancora oggi richiesti per mettere in orbita attorno alla terra o lanciare nello spazio complesse strumentazioni scientifiche non fa perdere attualità alla osservazione astronomica dalla superficie terrestre che necessita, appunto, di un cielo buio. Queste considerazioni hanno opportunamente suggerito all’IAU di sottolineare il valore della “luce cosmica”, di particolare importanza per la comunità astronomica, e che in questo Anno 2015 andrà più apprezzata, forse meglio difesa.
Come sempre, la capacità di ascoltare i segnali più deboli, provengano essi dallo spazio o dalla nostra personale riflessione quando facciamo silenzio nel nostro intimo, caratterizza la dignità della ricerca, quella scientifica come quella interiore. È su entrambe le dimensioni che il 2015 si propone di fare luce. Ed è quello che ci auguriamo.
© 2015 DISF – Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede
Molti hanno almeno sentito nominare i trascendentali moderni, intesi se non nel senso husserliano del termine quantomeno in quello kantiano: per Immanuel Kant, «trascendentale» è «ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti, in quanto questa deve essere possibile a priori» (Critica della ragion pura, Intr., sez. VII). Meno nota è l’esistenza di un significato previo di trascendentale, non solo più antico e frutto di una lunga elaborazione concettuale, ma carico di un più forte spessore metafisico, ancor meglio ontologico: i trascendentali elaborati in filosofia dal XII secolo in poi (ma non in modo monolitico), che trovano una magistrale espressione nel pensiero di Tommaso d’Aquino.
Perché scriverne qui – e perché del bello? A prima vista potrebbe sembrare tutt’altro che un tema interdisciplinare, meritevole tutt’al più di una curiosità erudita. In realtà, in questo momento i trascendentali godono di una rinnovata attenzione in filosofia a livello internazionale, ad esempio nell’attualissimo tomismo analitico ma non solo, (e fin qui la cosa potrebbe interessare solo i filosofi di professione). Per di più, come tutto ciò che si dice di ciò che è – e quindi in parole più povere, ma imprecise, di tutto ciò che esiste, quindi di ogni cosa, ogni vivente e ogni persona – riguardano in profondità il fine e lo svolgersi della ricerca scientifica nonché la ricerca stessa e il ricercatore che la compie... e con lui ogni essere umano. Se, quindi, anche il bello possa annoverarsi tra di essi è una questione che tocca in profondità anche chi si occupa di scienza. Anticipo, infatti, che la questione nel pensiero di Tommaso è ed è stata oggetto di discussione, con autorevoli interpreti schierati a favore dell’una o dell’altra interpretazione.
Cosa sono, allora, i trascendentali?
Comparsi per la prima volta con Filippo il Cancelliere († 1236), sebbene il termine (oggi filosoficamente consolidato) sia stato coniato solo molti anni più tardi con la tarda scolastica, i trascendentali sono appunto le determinazioni proprie di ogni ente in quanto ente. Cosa vuol dire?
Essi oltrepassano, trascendono appunto, le divisioni tra gli enti (ad esempio la differenza tra specie) perché si dicono di ogni “cosa” che è, proprio perché è. Usare il verbo essere è improprio, perché in questo contesto si pensa agli enti concreti e individuali e non ad un essere generico, ma si può dire comunque che così l’essere è “pieno”, essere significa “essere con certe caratteristiche”. In termini filosofici, i trascendentali si distinguono concettualmente dagli enti ma sono ad essi coestensivi. I più noti, ma non gli unici, sono l’uno («unum»), il vero («verum»), il buono («bonum»): essi indicano che ogni cosa è una, vera e buona – tanto più essa è.
Dietro l’apparente semplicità, si tratta di uno dei problemi più ardui della storia della filosofia, se non altro solo perché i termini del problema non si lasciano definire, strettamente parlando: sono talmente primi che non c’è nulla, di più generico di loro, che si possa usare per spiegarli.
Anche il bello è altrettanto primo, quantomeno per l’Aquinate?
Se l’ammissibilità del trascendentale bello è ancora oggi una questione aperta, tanto più lo era nel Medioevo, quando però la stragrande maggioranza degli autori non lo includeva nelle liste dei trascendentali. Negli scritti di San Tommaso non si trova un’esplicita presa di posizione in merito, ma il tema della bellezza, anche se non è affrontato in un trattato a sé stante, non solo è presente a margine (neanche così a margine, talvolta) di molti altri problemi, ma è per così dire vissuto dall’Aquinate, che non per niente fu autore di inni sacri ancora oggi molto amati nella liturgia della Chiesa cattolica, come il Pange lingua. Se non si possono forzare i suoi testi ad affermare qualcosa che non vi è scritto, tuttavia da un punto di vista logico, a partire da quanto vi si ritrova pagina dopo pagina, argomento dopo argomento, una conclusione si può comunque suggerire.
Ora, nel pensiero di San Tommaso, la bellezza è caratterizzata da alcuni elementi costitutivi, che sono «integrità o perfezione» (integritas sive perfectio), che indica la compiutezza e l’assenza di deformità o difetti di qualunque genere; «dovuta proporzione o armonia» (debita proportio sive consonantia), che indica la proporzione e il rapporto opportuno per ogni cosa; e «splendore» (claritas), che, nel suo senso più metafisico, indica come la bellezza risplenda e manifesti se stessa. Essi, infatti, devono essere intesi nella totalità della metafisica tommasiana, che li lega intimamente all’essere e li attribuisce non solo e non tanto alle realtà fisiche, quanto piuttosto allo stesso intelletto umano e sommamente alle realtà spirituali: è in queste ultime che si dà la bellezza maggiore (così come esse sono ontologicamente più perfette). La proporzione dovuta, ad esempio, in ultima analisi sembra raccordare ogni ente a Dio.
Dunque, non c’è equivocità tra bellezza corporea e bellezza spirituale e Dio è la fonte di entrambe: il mondo tommasiano è alieno da quelle divisioni che si affermeranno anche drammaticamente in autori successivi ed è fondamentalmente in armonia (ma non si dimentichi con ciò il peccato originale e ciò che esso porta con sé). Nello stesso tempo, per San Tommaso «belle sono le cose che viste piacciono» («pulchra dicuntur quae visa placent», Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 1). Il pulchrum intrattiene con il piacere (delectatio) un rapporto privilegiato, forse più del bene, ed un rapporto costitutivo: la bellezza appaga il desiderio (tecnicamente, l’Aquinate scrive l’«appetito») al solo guardarla, senza che sia necessario raggiungerla od appropriarsene in altro modo. Si noti che è il piacere intellettuale, che in questo caso è coinvolto in quanto deriva dalla bellezza intellettuale, ad avere una dignità maggiore: per San Tommaso, esso non è una semplice delectatio, che è propria anche degli animali, ma consiste più propriamente nel gaudium.
Quel che si può dire qui, dunque, è che se ogni ente è bello, allora la realtà per noi risplende e suscita il nostro piacere al solo guardarla (anche senza possederla). L’Aquinate insegna che la bellezza risplende nel mondo sensibile, ma non è confinata in esso e, anche se per noi è più difficile scorgerla, si trova sommamente al di là di esso – e anche negli argomenti razionali: possiamo legittimamente aggiungere nelle dimostrazioni matematiche e nelle teorie scientifiche.
Per tornare al nocciolo che ci interessa, è proprio se un ente è uno, identico con se stesso e tale da abbracciare le sue parti, che lo scienziato può avere un oggetto di studio, perché la molteplicità esasperata risulta necessariamente incomprensibile, forse anche fluttuante e caleidoscopica: l’intelletto non avrebbe un appoggio dove “fare presa”, ma solo un vortice sfuggente.
È perché la realtà è vera che può sperare di concludere con delle leggi che non siano solo costruzioni funzionali o utilitaristiche. Se la realtà si apre alla mia intelligenza, allora posso sperare con fondatezza di capirla, almeno in parte, in modo appropriato e concludente.
È perché la realtà è buona, che so che è un bene per me conoscerla – e che il mio sforzo per farlo è giustificato.
Infine, è perché la realtà è bella che ci attrae e ci dà gioia contemplarla – e anche per questo ci attrae fare ricerca, anche se non se ne scorge un’immediata utilità pratica.
La bellezza, per il ricercatore, – aggiungo – può essere un segno del bene, ma soprattutto un segno del vero – e costituire così un aiuto prezioso per la ricerca, a condizione, sia chiaro, di non divenirne il fine ultimo; è il vero (e il bene) che fiorisce in tutto il suo splendore. Sembra che nel pensiero dell’Aquinate si possa trovare una risposta a quell’interrogativo che suscitano i non pochi scienziati di professione (tra i quali Dirac) che indicano la bellezza di una nuova teoria come un potente criterio euristico se non addirittura di vaglio veritativo – e giustificarne almeno in parte le affermazioni.
Ma non finisce qui! Tutti questi perché si possono trovare anche sul ricercatore, dato che i trascendentali riguardano l’“oggetto” e il “soggetto”: è un esercizio che, evitando di dilungarmi troppo, affido al lettore. Indico solo il fatto che la bellezza di una teoria scientifica o, ancor meglio, della realtà che essa ci dischiude, può suscitare a ragione la gioia di chi la coglie e la fa sua.
I trascendentali tommasiani ci indicano che nella realtà si dispiega una fondamentale armonia. In conclusione, giustificano perché vale la pena fare ricerca scientifica... e perché farla ci piace.
 La lettera indirizzata a Cristina di Lorena granduchessa di Toscana fu iniziata da Galilei nel febbraio del 1615 e completata nell’estate dello stesso anno. I mesi occorsi alla composizione si spiegano per la cospicua mole dello scritto, che più che una lettera di chiarimento può essere definito un breve trattato teorico.
La lettera indirizzata a Cristina di Lorena granduchessa di Toscana fu iniziata da Galilei nel febbraio del 1615 e completata nell’estate dello stesso anno. I mesi occorsi alla composizione si spiegano per la cospicua mole dello scritto, che più che una lettera di chiarimento può essere definito un breve trattato teorico.
Era un momento cruciale per l’attività scientifica di Galilei: da quando nel 1610 il suo Sidereus Nuncius aveva fatto il giro dell’Europa il copernicanesimo non era più una semplice ipotesi o un mezzo utile a semplificare i calcoli astronomici, ma una tesi che le osservazioni lasciano prevedere si potesse giungere presto a dimostrare, scalzando così l’antichissimo dominio del geocentrismo. Abbattere la veneranda cosmologia aristotelico-tolemaica significava sconvolgere l’immagine antropocentrica dell’universo che si era venuta consolidando attraverso i secoli medievali. Così il problema della veridicità della teoria copernicana slittò presto da un terreno di sola filosofia al campo religioso e teologico, slittamento facilitato anche dal clima culturale post-tridentino che attraverso strumenti come l’indice dei libri proibiti favoriva la supervisione ecclesiastica sulla produzione intellettuale.
 Galilei era ben conscio del rischio che correvano le sue teorie e la sua stessa incolumità nel caso in cui fosse stato dichiarato eretico, ma allo stesso tempo dopo anni di ricerche era anche assolutamente convinto della verità dell’eliocentrismo. La sfida che gli si parò davanti tra il 1611 e 1615 fu dunque quella di pensare come potessero conciliarsi copernicanesimo e fede cristiana. Un temibile ostacolo era l’ostilità di alcuni versetti della Sacra Scrittura, come Gs 10,12-13, dove Giosuè alla battaglia di Gabaon comanda al sole di fermarsi. In un contesto in cui la filosofia naturale tendeva ad essere assorbita in una metafisica del sensibile ispirata cristianamente o in cui il naturale veniva letto come simbolo del soprannaturale era quasi spontaneo l’utilizzo del testo sacro nelle dispute scientifiche. Galilei fu così costretto dagli eventi a riflettere sui criteri di interpretazione della Bibbia per comprendere se veramente gli fosse tanto nemica.
Galilei era ben conscio del rischio che correvano le sue teorie e la sua stessa incolumità nel caso in cui fosse stato dichiarato eretico, ma allo stesso tempo dopo anni di ricerche era anche assolutamente convinto della verità dell’eliocentrismo. La sfida che gli si parò davanti tra il 1611 e 1615 fu dunque quella di pensare come potessero conciliarsi copernicanesimo e fede cristiana. Un temibile ostacolo era l’ostilità di alcuni versetti della Sacra Scrittura, come Gs 10,12-13, dove Giosuè alla battaglia di Gabaon comanda al sole di fermarsi. In un contesto in cui la filosofia naturale tendeva ad essere assorbita in una metafisica del sensibile ispirata cristianamente o in cui il naturale veniva letto come simbolo del soprannaturale era quasi spontaneo l’utilizzo del testo sacro nelle dispute scientifiche. Galilei fu così costretto dagli eventi a riflettere sui criteri di interpretazione della Bibbia per comprendere se veramente gli fosse tanto nemica.
Grazie forse ad un padre Barnabita, che gli fornì un dossier di testi antichi e moderni contenenti riflessioni sui rapporti tra ricerca scientifica ed esegesi biblica, Galilei poté verificare ed appoggiare sulla tradizione stessa della Chiesa le sue considerazioni, scoprendo proprio in Sant’Agostino un formidabile alleato. Infatti, già più di mille anni prima, i Padri della Chiesa incontrarono difficoltà molto simili nel tentativo di conciliare il portato ebraico-cristiano con la raffinata speculazione greca e romana. Come a Sant’Agostino si parò la sfida storica dell’inculturazione del linguaggio biblico all’interno dell’elegante riflessione classica simboleggiata dall’Ortensio ciceroniano, così per Galilei si poneva la difficoltà di rappacificare all’interno di un contesto già cristiano una verità di ragione con il pensiero religioso apparentemente contrario. La rivoluzione metodologica che si stava compiendo nel campo della filosofia naturale portava come inevitabile conseguenza una chiarificazione dei rapporti che questa forma di sapere intratteneva con la Sacra Scrittura.
 La lettera a Madama Cristina di Lorena rappresenta il tentativo teorico più maturo di Galilei in questo sforzo di chiarificazione e ristrutturazione del rapporto tra saperi, tentativo che mirava alla de-responsabilizzazione della Bibbia dal suo utilizzo come fonte d’autorità nella ricerca scientifica. Nella lettera Galilei si servì di quattro principi teorici fondamentali: il principio di inerranza (la Bibbia non può in alcun modo contenere affermazioni erronee), il principio dell’unica fonte delle verità (Scrittura e natura discendono entrambe da Dio, la prima come sua parola, la seconda come sua opera), il principio di limitazione (intenzione primaria della Bibbia è la salvezza degli uomini), il principio di prudenza (occorre essere molto attenti nell’interpretazione delle Scritture per evitare di impegnare il testo biblico nel sostegno di tesi errate). Galilei utilizzò questi quattro principi teorici per fondare il concetto chiave che doveva garantire l’autonomia di ricerca della filosofia naturale dall’autorità del testo sacro: non è mai metodologicamente corretto utilizzare versetti biblici come prove sperimentali. Questo criterio era già ravvisabile nel De Genesi ad Litteram agostiniano e non è un caso che Galilei lo citi abbondantemente.
La lettera a Madama Cristina di Lorena rappresenta il tentativo teorico più maturo di Galilei in questo sforzo di chiarificazione e ristrutturazione del rapporto tra saperi, tentativo che mirava alla de-responsabilizzazione della Bibbia dal suo utilizzo come fonte d’autorità nella ricerca scientifica. Nella lettera Galilei si servì di quattro principi teorici fondamentali: il principio di inerranza (la Bibbia non può in alcun modo contenere affermazioni erronee), il principio dell’unica fonte delle verità (Scrittura e natura discendono entrambe da Dio, la prima come sua parola, la seconda come sua opera), il principio di limitazione (intenzione primaria della Bibbia è la salvezza degli uomini), il principio di prudenza (occorre essere molto attenti nell’interpretazione delle Scritture per evitare di impegnare il testo biblico nel sostegno di tesi errate). Galilei utilizzò questi quattro principi teorici per fondare il concetto chiave che doveva garantire l’autonomia di ricerca della filosofia naturale dall’autorità del testo sacro: non è mai metodologicamente corretto utilizzare versetti biblici come prove sperimentali. Questo criterio era già ravvisabile nel De Genesi ad Litteram agostiniano e non è un caso che Galilei lo citi abbondantemente.
Per Galilei la Bibbia doveva essere scientificamente de-responsabilizzata perché tra natura e Scrittura, pur provenendo entrambe dal medesimo Verbo divino, vi è un’irriducibile disomogeneità sia di linguaggio (polifonico e plurale nelle Scritture, lineare e monocorde nella natura) che di scopi (per la Bibbia dare conoscenza di verità altrimenti irraggiungibili, per la natura seguire le leggi immutabili e necessarie volute da Dio). Il libro della natura è univoco, per chi possiede il sapere matematico-geometrico esso parla limpidamente senza metafore o allusioni. Le Sacre Scritture invece sono un testo complesso, pluristratificato e bisognoso di un attento lavoro di interpretazione: dietro il linguaggio spesso aspro usato per adattarsi all’intendimento dell’uomo comune la Bibbia nasconde per i dotti tesori di sapienza.
Affermata l’innovativa pretesa galileiana di dare un’assoluta autonomia di ricerca alle scienze naturali, occorre però sottolineare come permanga in Galilei la concezione, che condivideva con i suoi avversari, del testo biblico come enciclopedia di tutto il sapere umano. Questo è evidente nel finale della lettera a Madama Cristina di Lorena dove Galilei passa dal piano dell’enunciazione dei principi teorici a quello esegetico applicativo: una lettura copernicana della Bibbia non solo è possibile, ma addirittura porta ad un’interpretazione più semplice dei versetti biblici che non adottando il sistema tolemaico. Galilei non affermerà mai una radicale a-scientificità della Bibbia, certamente le Scritture hanno come scopo primario la salvezza spirituale del fedele, ma al contempo contengono in sé ogni verità del sapere. Per Galilei era possibile operare una lettura scientificamente edotta dei passi biblici: partendo dalle verità già dimostrate della ricerca sperimentale si può passare a interpretare le Scritture, scoprendo come le verità scientifiche ci aprano ad una comprensione più profonda dei versetti biblici. Questa concezione della Bibbia come testo misterico, come esoterico contenitore di tutto lo scibile umano, era tipica della cultura rinascimentale: mancava a Galilei e ai biblisti del suo tempo una chiara consapevolezza della formulazione storico-letteraria del testo biblico. Questa mancata consapevolezza fu uno dei motivi fondamentali della condanna del copernicanesimo nel 1616.
Dunque la lettera a Madama Cristina di Lorena, con le sue straordinarie intuizioni e limiti, rappresenta il tentativo di rideclinare la posizione epistemologica e autoritativa delle Sacre Scritture rispetto alla nuova metodologia di ricerca tipica delle scienze moderne; tentativo che si inquadra all’interno di una più vasta riconsiderazione dei rapporti tra ragione e fede in tutti gli ambiti della civiltà europea, laddove eventi come la scoperta delle Americhe, la Riforma e la rivoluzione copernicana avevano resa obsoleta l’antica armonia medievale. Pochi decenni dopo la lettera a Madama Cristina di Lorena figure di grandi pensatori come Thomas Hobbes e Baruch Spinoza avrebbero gettato le basi per una lettura illuministica del testo Sacro, abbandonando l’ormai frustrato spirito conciliativo galileiano e sferrando un attacco diretto alla rivelazione, in favore dell’approccio razionalista e ultimamente deista. Ora era la scienza stessa che si impadroniva della Bibbia, abbattendo la sua autonomia di fede e rileggendola in senso razionalistico come mero documento storico. Proprio da una visione così aliena sarebbe nato un grande dono per gli uomini di fede: infatti il metodo storico-critico, lungi dal desacralizzare le Scritture come taluni pensarono, consentì di approfondirne la dimensione storica e letteraria. Allo stesso tempo la scienza si è progressivamente liberata dalle letture materialistiche e positivistiche che ne hanno traghettato l’auto-comprensione nei secoli moderni, aprendo nuove proficue strade al dialogo tra scienza e fede.
 La Sindone, che sarà di nuovo esposta dal 19 aprile al 24 giugno, è un lino di colore giallino che misura cm 442 per cm 113 e reca impressa l’immagine frontale e dorsale di un uomo che è stato flagellato, coronato di spine, crocifisso e trafitto da una lancia al costato dopo la morte, proprio come descritto nei Vangeli.
La Sindone, che sarà di nuovo esposta dal 19 aprile al 24 giugno, è un lino di colore giallino che misura cm 442 per cm 113 e reca impressa l’immagine frontale e dorsale di un uomo che è stato flagellato, coronato di spine, crocifisso e trafitto da una lancia al costato dopo la morte, proprio come descritto nei Vangeli.
Da quando la reliquia è stata fotografata per la prima volta da Secondo Pia, nel 1898, molti scienziati hanno cominciato a interessarsi di questo particolare lenzuolo, che la Chiesa cattolica venera come telo funerario di Gesù. Il negativo fotografico del Pia aveva rivelato il positivo dell’immagine umana impressa sulla stoffa e questo permise ai medici legali di condurre una sorta di autopsia virtuale del cadavere non più presente nel Telo.
Nel 1978 una cinquantina di scienziati e ricercatori di diverse nazioni, prevalentemente statunitensi appartenenti allo STURP (Shroud of Turin Research Project, Progetto di Ricerca sulla Sindone di Torino), hanno condotto una investigazione scientifica multidisciplinare sulla reliquia, cosa che non era mai accaduta in passato. Essi fecero prelievi, misure e analisi sulla Sindone per 120 ore consecutive. I risultati di tale ricerca fornirono ampie conferme dell’autenticità della Sindone e costituiscono ancora oggi una solida base scientifica.
Il test del 14C
Il 21 aprile 1988 dalla Sindone fu prelevato un campione di tessuto per sottoporlo alla datazione con il metodo del radiocarbonio. In base a questa analisi, la Sindone risalirebbe al medioevo, a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 d. C.
Numerose obiezioni sono state mosse da vari scienziati, che ritengono insoddisfacenti le modalità dell'operazione di prelievo e l'attendibilità del metodo per tessuti che hanno subito vicissitudini come quelle della Sindone.
Interessanti analisi sono state condotte dal chimico Raymond N. Rogers del Los Alamos National Laboratory (USA), il quale ha riscontrato incrostazioni di coloranti e fibrille di cotone nel lino proveniente dalla zona del prelievo per l’analisi radiocarbonica. Il chimico statunitense conclude che il campione usato per la radiodatazione non era rappresentativo del tessuto sindonico originale per l’esistenza di un rammendo.
Per verificare l'antichità di un tessuto esistono però anche altri metodi. L’Ing. Giulio Fanti, professore associato di Misure Meccaniche e Termiche presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, ha sottoposto alcune fibre della reliquia a due datazioni chimiche, basate sulla spettroscopia vibrazionale, e a una datazione meccanica multiparametrica. Tutte e tre le datazioni risultano compatibili con la data del I secolo d.C.
L’indagine medico-legale
Dallo studio della Sindone alcuni medici deducono che fino a poco prima della morte fluiva sangue dalle ferite e che il corpo è stato avvolto nel lenzuolo non più tardi di due ore e mezzo dopo la morte. Il sangue presente sulla Sindone è colato verso il basso lungo le braccia, il corpo e le gambe di un uomo appeso a una croce; si è coagulato sulla sua pelle ed è anche fuoruscito con le caratteristiche di sangue post-mortale dalla ferita del costato.
Il breve tempo di permanenza del cadavere nel lenzuolo è testimoniato dall’assenza di segni di putrefazione. Vicino alle labbra mancano tracce di gas ammoniacali, che sarebbero certamente presenti nel caso di inizio di putrefazione. Generalmente questa comincia circa 40 ore dopo la morte. Il processo di putrefazione viene accelerato quando ci si trova in presenza di grandi ferite e di focolai contusivi, come nel caso dell'Uomo della Sindone.
Per avere un decalco del sangue sulla stoffa come quello osservato sulla Sindone, il corpo deve essere stato a contatto con il lenzuolo per circa 36-40 ore. In questo tempo un ruolo importante deve essere stato svolto dalla fibrinolisi, che provoca il ridiscioglimento dei coaguli. Resta inspiegabile come il contatto tra corpo e lenzuolo si sia interrotto senza alterare i decalchi che si erano formati.
Le caratteristiche dell’immagine
 L’immagine dell’Uomo della Sindone non è dovuta a sostanze applicate sul tessuto, ma all’ingiallimento delle fibrille superficiali della stoffa stessa, il cui numero per unità di area determina la maggiore o minore intensità della figura. La colorazione giallina è il risultato di una disidratazione e ossidazione che penetra solo per 0,2 millesimi di millimetro. Queste osservazioni sperimentali escludono la possibilità che l’immagine possa essere stata prodotta con pigmenti, con metodi chimici o con il riscaldando del tessuto, perché in questi casi la colorazione si sarebbe diffusa in profondità nella stoffa.
L’immagine dell’Uomo della Sindone non è dovuta a sostanze applicate sul tessuto, ma all’ingiallimento delle fibrille superficiali della stoffa stessa, il cui numero per unità di area determina la maggiore o minore intensità della figura. La colorazione giallina è il risultato di una disidratazione e ossidazione che penetra solo per 0,2 millesimi di millimetro. Queste osservazioni sperimentali escludono la possibilità che l’immagine possa essere stata prodotta con pigmenti, con metodi chimici o con il riscaldando del tessuto, perché in questi casi la colorazione si sarebbe diffusa in profondità nella stoffa.
È stato trovato solo un cristallino di cinabro, che è da considerarsi un reperto accidentale. L'esame di tutta la Sindone con la fluorescenza ai raggi X non ha rilevato alcun pigmento di pittura, quindi nemmeno cinabro; questa sostanza non può essere responsabile della colorazione delle macchie rosse, peraltro certamente composte da sangue, semplicemente perché non è presente.
Bisogna considerare che molti artisti hanno copiato dal vero la Sindone e quindi la presenza occasionale di pigmenti non è inaspettata; anche perché quasi sempre le copie venivano messe a contatto con l'originale per renderle più venerabili.
La figura umana visibile sulla Sindone è una proiezione verticale del cadavere su un piano orizzontale: c'è una corrispondenza in verticale fra il corpo e i punti corrispondenti dell'immagine. Esiste una correlazione fra l'intensità della figura e la distanza tela-corpo, che permette l'elaborazione tridimensionale dell’immagine.
Il telo ha avvolto un vero cadavere: le macchie di sangue sono dovute al contatto diretto con le ferite di un corpo umano. Sotto le macchie di sangue non esiste immagine del corpo: il fenomeno che ha impresso la figura umana sulla Sindone è avvenuto dopo che il sangue si era decalcato sul tessuto stesso e ne aveva attraversato lo spessore.
La teoria della radiazione
Nel corso degli ultimi decenni si sono tentate molte strade per spiegare come si sia formata l’immagine sindonica. In modo particolare, le caratteristiche chimiche, la superficialità e la sua assenza sotto le macchie di sangue hanno privilegiato l’ipotesi che una esplosione di luce potesse essere alla sua origine.
Già nel 1930 si era affacciata l'ipotesi, proposta da Noguier de Malijay, che l'impronta presente sulla Sindone potesse essere stata provocata da un fenomeno fotofolgorante legato alla risurrezione di Gesù. Nel 1966 Geoffrey Ashe ripropose tale ipotesi, che fu accettata successivamente da molti altri, fra i quali Giovanni Judica Cordiglia e Sebastiano Rodante.
 Il fisico John Jackson ha considerato alcune acquisizioni ormai fuori di dubbio: la grande definizione dei particolari della figura umana, che se fosse dovuta a diffusione o irraggiamento risulterebbe molto più sfocata; l'immagine è dovuta all’ingiallimento delle singole fibrille superficiali, il cui numero per unità di area determina la maggiore o minore intensità della figura; l'elaborazione tridimensionale è possibile grazie a una correlazione esistente fra l'intensità della figura e la distanza tela-corpo; la natura chimica dell'immagine è dovuta a degradazione per disidratazione e ossidazione delle fibrille superficiali senza sostanze di apporto; l'immagine è una proiezione verticale della figura su un piano orizzontale: c'è una corrispondenza in verticale fra il corpo e i punti corrispondenti dell'immagine; il telo ha avvolto un vero cadavere: le macchie di sangue sono dovute al contatto diretto con le ferite di un corpo umano; mancano tracce di immagine corporea laterale, mentre ci sono macchie di sangue laterali; sotto le macchie di sangue non esiste immagine del corpo: il sangue, depositatosi per primo sulla tela, ha schermato la zona sottostante mentre, successivamente, si formava l'immagine.
Il fisico John Jackson ha considerato alcune acquisizioni ormai fuori di dubbio: la grande definizione dei particolari della figura umana, che se fosse dovuta a diffusione o irraggiamento risulterebbe molto più sfocata; l'immagine è dovuta all’ingiallimento delle singole fibrille superficiali, il cui numero per unità di area determina la maggiore o minore intensità della figura; l'elaborazione tridimensionale è possibile grazie a una correlazione esistente fra l'intensità della figura e la distanza tela-corpo; la natura chimica dell'immagine è dovuta a degradazione per disidratazione e ossidazione delle fibrille superficiali senza sostanze di apporto; l'immagine è una proiezione verticale della figura su un piano orizzontale: c'è una corrispondenza in verticale fra il corpo e i punti corrispondenti dell'immagine; il telo ha avvolto un vero cadavere: le macchie di sangue sono dovute al contatto diretto con le ferite di un corpo umano; mancano tracce di immagine corporea laterale, mentre ci sono macchie di sangue laterali; sotto le macchie di sangue non esiste immagine del corpo: il sangue, depositatosi per primo sulla tela, ha schermato la zona sottostante mentre, successivamente, si formava l'immagine.
In base a tali considerazioni, Jackson ha ipotizzato che il telo, mentre si formava l'immagine corporea, abbia assunto una posizione diversa da quella che aveva mentre si formavano le macchie di sangue. Il lenzuolo si sarebbe macchiato di sangue mentre era adagiato sul corpo umano disteso; l'immagine, invece, si sarebbe formata a causa di un apporto energetico per contatto, mentre il telo pian piano si afflosciava attraversando il corpo, divenuto meccanicamente trasparente.
Un irradiamento di protoni
Molto interessanti sono anche gli esperimenti del biofisico Jean-Baptiste Rinaudo, ricercatore di medicina nucleare a Montpellier. Secondo questo scienziato, l'ossidazione acida delle fibrille superficiali della Sindone nelle zone dell'immagine, l'informazione tridimensionale contenuta nella figura e la proiezione verticale dei punti che compongono l'impronta si possono spiegare con un irradiamento di protoni che sarebbero stati emessi dal corpo, sotto l'effetto di un apporto di energia sconosciuta.
Rinaudo ritiene che gli atomi coinvolti nel fenomeno siano quelli del deuterio, presente nella materia organica: è l'elemento che ha bisogno della minore energia per estrarre un protone dal suo nucleo, che è formato da un protone e da un neutrone. È un nucleo stabile, quindi c'è stato bisogno di un apporto di energia per romperlo. I protoni avrebbero formato l'immagine, mentre i neutroni avrebbero irradiato il tessuto, con il conseguente arricchimento in 14C che avrebbe falsato la datazione. Interessante il fatto che il successivo invecchiamento artificiale dei campioni rinforza le colorazioni delle ossidazioni ottenute.
Un altro studio significativo è stato condotto da un medico, August Accetta, il quale ha condotto un esperimento su se stesso iniettandosi una soluzione di difosfato di metilene contenente tecnezio-99m, un isotopo radioattivo che decade rapidamente. Ogni atomo di tecnezio emette un unico raggio gamma, che può essere registrato da una apposita apparecchiatura di rilevamento. L’obiettivo era quello di realizzare un’immagine provocata da una radiazione emessa da un corpo umano. Secondo Accetta, infatti, l’immagine sulla Sindone potrebbe essere stata causata dall’energia sprigionatasi all’interno del corpo di Cristo al momento della risurrezione.
Gli esperimenti con il laser
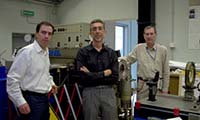 Presso l’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) di Frascati (Roma), un gruppo di fisici ha realizzato esperimenti molto importanti. Alcune stoffe di lino sono state irradiate con un laser a eccimeri, che emette una radiazione ultravioletta ad alta intensità. I risultati, confrontati con l’immagine sindonica, mostrano interessanti analogie: la colorazione è simile ed è limitata alla parte superficiale del tessuto. Viene così confermata la possibilità che l’immagine sindonica sia stata provocata da una radiazione ultravioletta direzionale. La colorazione del lino diventa più intensa con il trascorrere del tempo.
Presso l’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) di Frascati (Roma), un gruppo di fisici ha realizzato esperimenti molto importanti. Alcune stoffe di lino sono state irradiate con un laser a eccimeri, che emette una radiazione ultravioletta ad alta intensità. I risultati, confrontati con l’immagine sindonica, mostrano interessanti analogie: la colorazione è simile ed è limitata alla parte superficiale del tessuto. Viene così confermata la possibilità che l’immagine sindonica sia stata provocata da una radiazione ultravioletta direzionale. La colorazione del lino diventa più intensa con il trascorrere del tempo.
«Sono necessari – sottolinea il fisico Giuseppe Baldacchini - impulsi di luce ultravioletta molto dura, di durata inferiore a cento miliardesimi di secondo e con potenze di almeno qualche centinaio di megawatt, ma non troppo di più. Quindi siamo in presenza di processi a soglia e a finestra di tipo foto-chimico e non fototermico, che invece inducono bruciature». «Con una serie di ragionamenti logici e di fatti sperimentali e storici – prosegue Baldacchini – è possibile dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la Sindone è stata realmente il lenzuolo funebre utilizzato per coprire il cadavere di Gesù Cristo circa 2000 anni fa, dopo essere stato flagellato e crocifisso in Gerusalemme, come è stato descritto nei Vangeli. Rimane però da scoprire – conclude il fisico – come sia stata creata l’immagine corporea sul lenzuolo funebre e come abbia fatto il corpo di Gesù a uscire dalla tomba e in particolare dalla Sindone, che al mattino dopo la risurrezione era semplicemente distesa (afflosciata) sulla pietra del sepolcro. Le nostre misure ci dicono che una esplosione di energia radiante è compatibile con la formazione dell’immagine corporea».
Davvero questo esperimento arriva fin sulla soglia del mistero di quell’impronta, che richiama il mistero centrale della fede cristiana. Così lo esprimeva Benedetto XVI in occasione della sua visita a Torino il 2 maggio 2010, durante una meditazione tenuta di fronte alla Sindone: «Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là, dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova: la luce della Risurrezione. Ed ecco, mi sembra che guardando questo sacro Telo con gli occhi della fede si percepisca qualcosa di questa luce. In effetti, la Sindone è stata immersa in quel buio profondo, ma è al tempo stesso luminosa».
Nella rivista "Il Regno", [LIX, n. 1177, 15 novembre 2014, pp. 710-713)] e nell' “Annuario filosofico”, [(ISSN 0394-1809), n. 29 (2013), novembre 2014, pp. 242-275, ISBN: 9788842554851] è stato pubblicato un contributo di Paolo Becchi (Università di Genova) e Roberto Franzini Tibaldeo (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) che propone un confronto tra le riflessioni in tema di creazione di Hans Jonas e Joseph Ratzinger. Ne riportiamo come editoriale una sintesi curata dal professor Franzini Tibaldeo.
Altrimenti noto come «dibattito sulle origini», la disputa tra creazionismo ed evoluzionismo ruota intorno alle ipotesi contrastanti circa le origini dell’universo, della Terra, della vita e della stessa umanità. Dinanzi alla regolarità e all’ordine esistenti nel cosmo, così come dinanzi all’innegabile dinamica che contrassegna determinate entità, quali le forme viventi, viene infatti spontaneo interrogarsi sulla consistenza della materia del mondo e domandarsi in base a quale principio si possa spiegare l’evoluzione del cosmo e in particolare del sistema terrestre, nel quale sono via via apparse forme organiche tra le più sofisticate. Negli ultimi decenni lo spazio del contendere si è polarizzato intorno alle posizioni vicendevolmente antitetiche dei creazionisti (si veda l’esempio paradigmatico delle teorie nordamericane promotrici dell’«Intelligent Design», tra i cui ispiratori si annoverano Michael J. Behe, Philipp E. Johnson, William A. Dembski e Stephen C. Meyer) e degli evoluzionisti (si pensi, per esempio, a Daniel C. Dennett e Richard Dawkins), accomunati dalla volontà di mantenere un monopolio mediatico e una primazia culturale sulle questioni dibattute.
Come spesso però accade, laddove il dibattito viene cannibalizzato da estremi così polarizzati, lì si finisce per smarrire quel ventaglio di posizioni e contributi intermedi che hanno invece il merito di richiamare in modo equilibrato l’attenzione su aspetti scientifici, filosofici e culturali di interesse generale. Quel che tenteremo di fare è accostare due di tali contributi intermedi, quello del filosofo Hans Jonas e quello del teologo Joseph Ratzinger. La tesi che argomenteremo è che il confronto reciproco permette di comprendere più a fondo e criticamente il pensiero di entrambi, specie sotto il profilo del rapporto con la modernità e con le sfide conoscitive ed etiche che con essa si aprono. Con una precisazione, però: accostare e mettere a confronto le loro riflessioni non significa sottacerne le divergenze.
*
Come accennato, la radicalizzazione del dibattito sulle origini tra «-ismi» contrapposti (creazionismo ed evoluzionismo) non è esaustiva né delle posizioni in campo, né della complessità delle questioni affrontate. E tuttavia proprio da qui può essere utile partire per chiarire a livello preliminare i termini del problema. Com’è noto, negli ultimi anni la querelle è tornata alla ribalta complici – tra gli altri – due avvenimenti di portata internazionale: la pubblicazione, in data 7 luglio 2005, sul «New York Times» di un articolo del cardinale Christoph Schönborn intitolato Finding Design in Nature, che sembrava rilanciare le posizioni creazionistiche, e le celebrazioni, nel 2009, dell’anno darwiniano (200 anni dalla nascita e 150 dalla pubblicazione de L’origine delle specie), che hanno ridato attualità alle tesi evoluzionistiche.
*
Non tutti i sostenitori del fatto che l’origine del mondo sia da riferirsi a un intervento creatore divino si riconoscono nelle forme più ostentate di creazionismo e nel contestuale rigetto senza mezzi termini dell’evoluzionismo. Tra le posizioni a questo riguardo più interessanti, si segnalano proprio quelle di Hans Jonas e Joseph Ratzinger. Per entrambi il problema di fondo è come rendere ragione dell’esistenza effettiva dello spirito umano, senza con ciò ricadere in una delle due soluzioni estreme. Jonas e Ratzinger condividono l’assunto di fondo secondo cui l’esistenza dello spirito umano richiederebbe al contempo due condizioni: a) che la materia sia dotata della possibilità della realizzazione dello spirito e b) che vi sia all’origine delle cose uno spirito trascendente e sovratemporale come sua causa prima.
La prima delle condizioni menzionate poggia a sua volta su due assunti, condivisi da entrambi gli autori. Il primo di questi assunti è che il mondo è dotato di razionalità e ordine: la sua esistenza si deve a ben più che al solo caso o – per dirla con Monod – alla sola combinazione di caso e necessità. Per entrambi, dunque, il darwinismo sarebbe sostanzialmente problematico: per il teologo l’evoluzionismo sarebbe infatti responsabile di minare la razionalità della natura, mentre per Jonas esso si avvilupperebbe in una serie di paradossi, tra cui quello di spiegare l’evoluzione più nei termini di una deviazione patologica, che in quelli di uno sviluppo sensato. Per Ratzinger, l’ordine del mondo è ricondotto direttamente all’esistenza e all’azione divine: «la fede della Chiesa si è sempre attenuta alla convinzione che tra Dio e noi, tra il suo eterno Spirito creatore e la nostra ragione creata esista una vera analogia, in cui certo le dissomiglianze sono infinitamente più grandi delle somiglianze, non tuttavia fino al punto da abolire l’analogia e il suo linguaggio» (Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, Regensburg, 12 settembre 2006). È questo il fondamento su cui poggiano dunque i dati di fatto della «struttura razionale della materia» e della «corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura». Jonas, da filosofo, si limita a rilevare la naturale ed evidente percezione di una regolarità e un ordine presenti nel cosmo (le leggi e forze fisiche, l’organizzazione della materia in strutture ordinate, ecc.), a cui si aggiunge poi un ordine di più elevata complessità, rappresentato dalla vita che «si presenta come una successione ascendente di gradi che va dal “primitivo” all’“evoluto”», fino a comprendere lo spirito umano in quanto «prefigurato sin dall’inizio nell’organico» (Organismo e libertà, 1966, 1973). L’interrogativo che però a questo punto si pone (e rimane provvisoriamente aperto) è: in base a quale principio evolutivo si può spiegare lo sviluppo della materia del mondo, e ciò tanto più alla luce dell’enigma costituito dalla «direzione anti-entropica intrapresa – improbabile per la fisica – dal disordine all’ordine» (Materia, spirito e creazione, 1988).
Il secondo assunto che accomuna Jonas e Ratzinger è la critica della pretesa moderna di voler espungere dal reale qualsivoglia differenza qualitativa (tra cui quella tra materia e spirito). Questo è infatti il risultato che si consegue mediante l’applicazione del metodo scientifico moderno in generale, un metodo d’indagine che fa dell’ipotesi materialistica la propria necessaria premessa metodologica. Il problema – puntualizzano Jonas e Ratzinger – nasce nel momento in cui il materialismo cessa di essere metodologico e aspira a diventare qualche cosa di diverso, vale a dire una dottrina ontologica che offre una spiegazione compiuta della realtà. Il che certamente non può essere, poiché le sue premesse (parziali e selettive per definizione) sono ben altre e non possono ambire a questo.
Veniamo così alla seconda condizione, vale a dire le prerogative di quella porzione di essere generalmente definita come «spirito». Lo spirito esprimerebbe la differenza specifica dell’essere umano rispetto a ciò che lo circonda. Lo scarto tra spirito e realtà naturale sarebbe di natura qualitativa e in nessun modo riconducibile a una mera differenza quantitativa. È evidente che a questo punto occorre, per un verso, mostrare come il «primato e la superiorità dello spirito» si concilino con il fatto che – per dirla con Ratzinger – «la direzione dell’evoluzione e il suo carattere di progresso sono, in fin dei conti, indiscutibili» e, per altro verso, confutare l’adeguatezza della lettura darwinista, secondo cui l’uomo nella sua interezza sarebbe un prodotto dell’evoluzione. Se infatti su questo punto si fallisse – prosegue Ratzinger – ci si troverebbe dinanzi a una conseguenza assai problematica: vale a dire, la «rigorosa contrapposizione: o - o, la quale non permette nessuna mediazione. Ma questo significherebbe, in base allo stato attuale della nostra scienza, la fine della fede nella creazione» (Fede nella creazione e teoria evoluzionista, 1969).
Sia per Ratzinger sia per Jonas la delicata questione di che cosa sia lo spirito si lega dunque per un verso al rapporto di quest’ultimo con la materia del mondo e per altro verso alla corretta interpretazione del rapporto che lega l’essere umano alla trascendenza divina. Nel caso in cui la vicenda cosmica – all’interno di cui si iscrive l’esistenza umana – altro non fosse che mero frutto del caso e mera avventura materiale (come è per l’evoluzionismo di tipo riduzionistico) o, viceversa, la lineare e preordinata realizzazione di un piano divino (come è per l’«Intelligent Design»), verrebbe meno il significato autentico della trascendenza divina, del suo ruolo nella creazione del mondo e della sua rilevanza per lo spirito umano.
Quale via percorrere dunque per sviluppare una corretta comprensione di tali questioni?
*
La proposta jonasiana, contenuta per lo più nel saggio Materia, spirito e creazione (ma si vedano anche Immortalità ed esistenza odierna, 1962, e Il concetto di Dio dopo Auschwitz, 1987), cerca di conciliare le due istanze precedentemente enunciate (che la materia sia dotata della possibilità della realizzazione dello spirito e che vi sia all’origine delle cose uno spirito trascendente e sovratemporale come sua causa prima) riconducendo l’origine del mondo alla scelta primordiale e imperscrutabile della divinità di «contrarsi» o «auto-negarsi», vale a dire di rinunciare alla propria onnipotenza per lasciare spazio all’autonomia cosmica e alle sue chance. Questo garantirebbe alla divinità una certa rilevanza cosmica, facendo al tempo stesso del suo ruolo e della sua azione nel mondo qualche cosa di completamente diverso rispetto a qualsivoglia «disegno intelligente». Jonas elabora le sue riflessioni in forma ipotetica e narrativa, attingendo in maniera innovativa alla tradizione qabbalistica ebraica: «perché il mondo sia e sia per se stesso, Dio rinunciò al proprio essere; si spogliò della sua divinità per riceverla indietro dalla sua odissea del tempo, carica del raccolto casuale dell’imprevedibile esperienza temporale, trasfigurata o forse anche sfigurata da essa» (Immortalità ed esistenza odierna). Il racconto mitico ha il pregio di restituire uno sguardo radicale sull’umano non disgiunto da una certa sobrietà dell’indagine intorno al divino. Questo risultato viene conseguito a partire da un’analisi di ciò che si manifesta nel cosmo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente le ragioni della responsabilità umana: l’evoluzione cosmica arriva infatti «a noi, gli unici detentori a noi noti dello spirito, ossia […] di un agire che alla luce del conoscere diviene sempre più potente […] Non v’è alcun dubbio che nelle nostre mani si trova la possibilità di deludere l’intenzione della creazione […]. Per quale motivo non ci è però permesso di procedere in questa direzione? […] Il dovere, che esiste da sempre, diviene acuto e concreto con l’incremento del potere umano attraverso la tecnica, la quale si rivela pericolosa per tutto l’abitare della vita qui sulla Terra […]. Esso ci dice che ora dobbiamo difendere da noi stessi la causa divina nel mondo che abbiamo messo in pericolo con il nostro agire. Ci dice che dobbiamo soccorrere contro noi stessi la divinità per se stessa impotente» (Materia, spirito e creazione).
Anche Ratzinger ritiene che occorra effettuare una decisa scelta di campo in favore dell’atto creativo divino: «Per svilupparsi ed evolversi – afferma il teologo – il mondo deve prima essere, e quindi essere passato dal nulla all’essere. Deve essere creato, in altre parole, dal primo Essere che è tale per essenza» (Discorso all’Assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle scienze, 31 ottobre 2008). Benché il pensiero ratzingeriano si connoti in maniera diversa rispetto alla creazione per sottrazione del Dio jonasiano, ciò che però lo avvicina al filosofo è il rilievo conferito alla creazione divina in vista della retta comprensione della specificità dello spirito e del senso dell’evoluzione. Ratzinger, infatti, afferma che «l’alternativa materialismo o visione spirituale del mondo, caso o mente direttiva, ci si presenta oggi sotto la forma della questione di considerare lo spirito e la vita, nelle loro forme salienti, soltanto come una muffa casuale sulla superficie del materiale (cioè dell’esistente che non comprende se stesso) oppure di vederli come il traguardo del divenire e di considerare, invece, la materia come preistoria dello spirito. Se si sceglie la seconda risposta è evidente che lo spirito non è un prodotto casuale di sviluppi materiali, ma piuttosto che la materia è un momento nella storia dello spirito. Questo è un diverso modo di esprimersi per affermare che lo spirito è creato e non è un puro prodotto dell’evoluzione, anche se si manifesta nella forma dell’evoluzione» (Fede nella creazione e teoria evoluzionista).
Tuttavia, sia per Ratzinger sia per Jonas la questione delicata è come rendere ragione dell’evidenza trascendente dello spirito nel mondo e del suo intreccio non occasionale con l’evoluzione materiale senza ricadere in posizioni teoricamente problematiche e scientificamente insostenibili, quali appunto l’«Intelligent Design», che a questo riguardo ha la pretesa di annullare la distinzione tra il piano naturale-biologico e quello teologico.
Rifacendosi a un’omelia di Avvento di Bernardo di Chiaravalle sul tema dell’annunciazione, Benedetto XVI infatti scrive: «Dopo il fallimento dei progenitori, tutto il mondo è oscurato, sotto il dominio della morte. Ora Dio cerca un nuovo ingresso nel mondo. Bussa alla porta di Maria. Ha bisogno della libertà umana. Non può redimere l’uomo, creato libero, senza un libero “sì” alla sua volontà. Creando la libertà, Dio, in un certo modo, si è reso dipendente dall’uomo. Il suo potere è legato al “sì” non forzato di una persona umana. Così […], nel momento della domanda a Maria, il cielo e la terra, per così dire, trattengono il respiro» (L’infanzia di Gesù, 2012).
Quanto a Jonas, benché il «Dio Signore e creatore di tutte le cose» non trovi riscontro nella sua riflessione, non si può che registrare una consonanza con la tonalità emotiva del brano ratzingeriano appena citato. Certo, alla divinità creatrice jonasiana non ci si può rivolgere con il pronome «tu» e la libertà di cui gode l’essere umano dinanzi a essa non assume i tratti della libertà del figlio, di cui parla Ratzinger. D’altronde, lo spazio che grazie alla propria auto-rinuncia la divinità jonasiana riesce ad assicurare al mondo e agli esseri umani non è solcato da un progetto specifico o da «un movimento che fa da battistrada» e che «arriva al traguardo a lui assegnato» (così Ratzinger in Fede nella creazione e teoria evoluzionista). Al contrario, si tratta di uno spazio contingente, autonomo, aperto e davvero non-ancora-deciso in cui l’agire umano è comunque chiamato a esercitare la propria libertà, facendosi carico della propria responsabilità per gli altri e per il mondo. Non è dunque uno spazio di indifferenza o privo di tessitura normativa. Né come tale è considerato dalla divinità, che segue con apprensione, speranza e partecipazione l’evolversi del mondo con le sue vicende. Piuttosto, rispetto al Dio cristiano, che parimenti si spoglia della propria divinità e si consegna al mondo, il Dio jonasiano sembra maggiormente disposto a esporsi, fin dalla notte dei tempi, al folle rischio del fallimento.
Pur non negando le molte e significative somiglianze, possiamo dunque affermare che la dottrina ratzingeriana della creazione differisca notevolmente dalla proposta jonasiana. Lo stesso può dirsi anche per altri aspetti del pensiero di Jonas e Ratzinger, che vorremmo qui sinteticamente richiamare. Innanzitutto, il tema della modernità, che è all’origine di un certo modo di intendere l’evoluzione. Certo, per un verso, Ratzinger si mostra grato allo spirito moderno «per le grandiose possibilità che esso ha aperto all’uomo e per i progressi nel campo umano che ci sono stati donati»; eppure, per altro verso, egli si affretta a mettere l’«ethos della scientificità» moderna sotto la tutela di quell’autorità più grande che è l’«obbedienza alla verità», la quale si svela nella fede, e a ricondurlo entro i binari di un «atteggiamento che fa parte della decisione di fondo dello spirito cristiano» (Fede, ragione e università). Se a questo riguardo è certamente vero che anche per Jonas il metodo scientifico moderno sia inadatto ad affrontare le questioni di senso, egli non si sente però in dovere di trovare un accordo a ogni costo con la ragione e il metodo scientifico moderni. La differenza di vedute può persistere e, anzi, di fatto così accade. Tuttavia, al tempo stesso, proprio il fatto di non dover per forza ricomporre le differenze in una qualche superiore unità o visione d’insieme consente a Jonas di cogliere – più di quanto sembri fare la prospettiva del «grande Logos» di cui parla Ratzinger (Fede, ragione e università) – alcune ragioni e istanze di legittimità della modernità altrimenti non ravvisabili. In altre parole, Jonas non incorre nell’ambivalenza ratzingeriana di voler interloquire filosoficamente con la modernità (e la teoria dell’evoluzione), ma tenendosene discosto in nome di un’istanza veritativa fondata teologicamente. Pure accomunate da una critica a determinati aspetti della modernità, le riflessioni di Jonas e quelle di Ratzinger differiscono dunque notevolmente: la prima cerca di comprendere – per così dire – la modernità dall’interno e predispone una proposta filosofica che cerca di oltrepassarne i limiti, mentre l’altra muove dall’esterno e le rimane sostanzialmente estranea, salvo però avere la pretesa di ricondurla a una verità superiore.
In Italia il dibattito scientifico sulle cellule staminali embrionali è particolarmente acuto. Effettuando un’estrema semplificazione, possiamo individuare due posizioni: la prima vede autorevoli scienziati che, sottolineando la grande possibilità terapeutica che tali cellule potrebbero avere, reputano corretto l’impiego di embrioni umani anche a costo di comprometterne l’esistenza; la seconda, invece, comprende quegli scienziati che, prima di imbattersi in discussioni di qualsivoglia natura sull’identità dell’embrione umano, tendono a sottolineare i mai superati limiti delle staminali embrionali sul terreno applicativo. Limiti che invece non hanno le cellule staminali adulte, già efficaci in svariate decine di protocolli terapeutici, buona parte dei quali portati avanti proprio in Italia.
Le cellule staminali esistono e funzionano fisiologicamente nei nostri tessuti. La medicina rigenerativa guarda con attenzione alle competenze di tali cellule con l’intento di implementarne le capacità a scopi terapeutici. È infatti la loro elevata capacità proliferativa (di grado diverso a seconda della staminale in questione) e la loro propensione a differenziarsi, dando origine a tipi cellulari specializzati e a nuovi tessuti, a fornire “il principio attivo” della terapia rigenerativa. Le staminali sono un tipo di cellule davvero straordinario, perché sanno fare due cose: riprodursi e specializzarsi. La capacità di riprodursi è tipica di ogni cellula, ma le staminali hanno la proprietà di auto-rigenerarsi e, dunque, di attraversare indenni un numero di cicli cellulari superiore a quello di altre cellule (la cellula staminale si divide e produce copie di se stessa per un tempo indefinito). La capacità, invece, di trasformarsi per svolgere un lavoro specializzato è tipica solo delle staminali. Tutte le altre cellule del corpo di un organismo sono ben differenziate e svolgono una funzione specifica: ci sono le cellule della pelle, quelle del cuore, quelle del sistema nervoso.
Nell’organismo umano esistono circa 250 tipi di cellule differenziate diverse. Un citologo le riconosce facilmente, spesso a vista, perché ciascun tipo ha la sua forma e la sua funzione. Le cellule staminali no. Non hanno una funzione. Se ne stanno lì, indifferenziate, ma pronte a trasformarsi – dopo un preciso segnale biochimico – in una cellula della pelle, in un neurone, in una cellula cardiaca o in qualsiasi altro tipo di cellula differenziata. È questa alta prolificità e questa capacità trasformistica a renderle uniche; ed è per queste capacità che i ricercatori guardano, da anni, alle cellule staminali come a un potenziale strumento per sostituire cellule e ricreare tessuti malati o danneggiati. Non tutte le cellule staminali sono uguali. In base alle loro potenzialità esse vengono classificate in: cellule staminali uni potenti capaci di trasformarsi in un solo tipo di cellula differenziata, ovvero possono dare luogo solo ad uno specifico tessuto; multi potenti sono cellule staminali adulte e tessuto specifiche, dette anche somatiche, presenti nei diversi tessuti del feto e dell‘organismo adulto e in grado di differenziarsi solamente nei tipi cellulari del tessuto di cui fanno parte; al gruppo delle cellule staminali pluripotenti appartengono,invece, due tipologie cellulari: quelle presenti transientemente nella blastocisti(fase sviluppata dell’embrione costituita da una massa differenziata di alcune centinaia di cellule) che prendono il nome di cellule staminali embrionali, il cui prelievo comporta la morte delle blastocisti e le cellule iPS ( cellule dalla pluripotenza indotta) di cui ci occuperemo tra poco, che sono il risultato di una recente scoperta che prevede una manipolazione in laboratorio; totipotente per eccellenza è lo zigote , una cellula che può differenziarsi dando vita ad un organismo completo. Restano staminali totipotenti anche le cellule dell’embrione nei primissimi stadi di sviluppo. La totipotenza non dura a lungo in seguito alle divisioni dello zigote, ma viene persa dopo lo stadio a otto cellule (2 – 3 gg dopo la fecondazione).
Una delle scoperte più recenti nel campo delle cellule staminali riguarda la possibilità di ottenere cellule simili a quelle embrionali a partire da cellule adulte dell’organismo. Questa scoperta è l’equivalente di una rivoluzione nel mondo della ricerca sulle cellule staminali e molti scienziati pensano che cambierà completamente il loro futuro uso in medicina. È il 2006 quando il ricercatore giapponese Shinya Yamanaka, dell’Università di Kyoto, scopre un metodo per fare “ringiovanire” delle cellule prelevate dal tessuto sottocutaneo di un topo, ottenendo cellule simili alle staminali pluripotenti presenti nell’embrione. Queste cellule staminali, prodotte artificialmente in laboratorio, sono state definite cellule staminali pluripotenti indotte o cellule iPS (dall’inglese induced Pluripotent Stem). L’anno dopo, nel 2007, la stessa tecnica è stata applicata con successo anche all’uomo dal gruppo di Yamanaka, e indipendentemente dai ricercatori americani capitanati da James Thomson: fibroblasti umani (cellule prelevate da tessuto cutaneo) vengono riportati allo stadio di cellule “bambine”. Per indicare questo processo di ringiovanimento delle cellule adulte gli scienziati hanno usato il termine riprogrammazione, per cui si sente spesso parlare di cellule staminali riprogrammate. Quindi le cellule iPS sono un tipo di cellula staminale pluripotente derivata da una cellula non pluripotente (tipicamente una cellula somatica adulta), attraverso la manipolazione di alcuni geni. Le cellule iPS aprono enormi prospettive per l’utilizzo di queste cellule staminali nello studio delle malattie in ambito clinico. Esse infatti associano la pluripotenza e la potenzialità differenziativa delle cellule staminali embrionali al fatto di poter essere ottenibili dall’ individuo stesso. Quindi teoricamente permetterebbero lo sviluppo di terapie cellulari personalizzate basate sull’impianto di cellule iPS ottenute dai propri fibroblasti e successivamente istruite a generare sottotipi di cellule specializzate di interesse. La tecnica utilizzata da Yamanaka e da Thomson consiste nell’introdurre all’interno delle cellule adulte del materiale genetico caratteristico delle cellule staminali sotto forma di un cocktail di quattro geni. Ciò permette di ringiovanire i fibroblasti fino a farli ritornare ad essere cellule staminali riprogrammate, ossia cellule che possiedono tutte le potenzialità delle cellule staminali embrionali pluripotenti: la capacità di autorinnovarsi e quella di specializzarsi in qualsiasi tipo di cellula dell’organismo. Per introdurre i quattro geni nelle cellule da ringiovanire, i ricercatori hanno utilizzato dei virus modificati in modo da contenere l’informazione genetica. Questi virus, messi a contatto con le cellule, le infettano fungendo così da vettori per i geni in questione.
La scoperta che è possibile ottenere cellule pluripotenti a partire da cellule già specializzate ha infatti acceso grandi speranze tra gli scienziati e nella società per la ipotizzata possibilità di eliminare il controverso utilizzo delle staminali embrionali umane nella ricerca e negli usi clinici. Tra l’altro, la derivazione di cellule pluripotenti direttamente dal paziente tramite il prelievo di una piccola porzione di tessuto presenterebbe il vantaggio di eliminare il problema del rigetto da parte del sistema immunitario del paziente, a differenza di quanto potrebbe verificarsi con le cellule staminali embrionali. Nel frattempo la ricerca sulle iPS continua ad andare avanti, raggiungendo altre tappe fondamentali che hanno ulteriormente rafforzato le speranze riposte su queste cellule per curare malattie ancora incurabili. Tra queste ricerche, nel 2008, uno studio condotto da ricercatori americani dell’Università di Cambridge ha dimostrato la possibilità di ottenere, a partire da fibroblasti della pelle, neuroni perfettamente funzionanti in grado di rimpiazzare quelli degenerati in un modello animale della malattia di Parkinson. In altre parole, le cellule iPS sono state fatte diventare cellule nervose e, trapiantate nel cervello di topi malati, sono riuscite ad attenuare i disturbi motori tipici del morbo di Parkinson permettendo un certo recupero funzionale. Recentemente, purtroppo, la speranza di poter utilizzate le cellule iPS a fini terapeutici è stata ridimensionata in seguito ai risultati di quattro diverse ricerche divulgate nei primi mesi del 2011, concordanti sulla tendenza delle cellule iPS a trasformarsi in cellule tumorali più facilmente rispetto alle cellule staminali embrionali. Tre di questi studi, pubblicati e commentati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, hanno rivelato il “lato oscuro” delle iPS che consiste nella tendenza a generare alterazioni nella sequenza del DNA e nei cromosomi in misura molto maggiore di quanto osservato nelle staminali embrionali fatte crescere in laboratorio. Il quarto studio, condotto da ricercatori italiani ha dimostrato che le cellule riprogrammate presentano un’instabilità del DNA simile a quella delle cellule tumorali, confermando la necessità di ulteriori studi che prima di passare alla sperimentazione sull’uomo. Queste ultime scoperte suggeriscono che le cellule iPS siano diverse dalle staminali pluripotenti estratte dagli embrioni e che forse non potranno sostituirle del tutto. Anche se questa può sembrare una cattiva notizia, in realtà rappresenta un ulteriore passo in avanti nella conoscenza delle cellule staminali. C’è ancora bisogno di pazienza e di molta cautela nel passaggio dal laboratorio al paziente, perché è indispensabile che a monte di questo percorso, ci sia una solida e approfondita conoscenza della biologia delle cellule staminali e dei meccanismi molecolari e funzionali che le caratterizzano. Conoscenza che si ottiene soltanto attraverso una solida ricerca di base e una attenta ricerca pre-clinica, cui devono necessariamente seguire sperimentazioni cliniche ancora più rigorose, che siano in grado di garantire sia la sicurezza sia l’efficacia delle terapie proposte. Se è infatti legittimo riporre delle aspettative ragionevoli sui risultati ottenibili attraverso l’impego clinico delle cellule staminali, è scorretto investire queste cellule di promesse irrealistiche come quelle alimentate dalla falsa credenza che possano costituire una sorta di panacea per tutti i mali, in grado di rigenerare qualsiasi tessuto del corpo umano. Spesso i pazienti, purtroppo abilmente manovrati da scienziati senza scrupoli, sono portati a credere che un trial clinico che sembra promettente in vitro o in vivo (sul topo) possa essere disponibile in tempi brevissimi come terapia sicura ed efficace. In realtà questo passaggio è estremamente lungo e complesso e spesso non dà i risultati sperati, soprattutto se non vengono scrupolosamente eseguite tutte le fasi di ricerca e sperimentazione. Le terapie cellulari così come la medicina rigenerativa sono sempre più basate sui progressi della biologia delle cellule staminali e hanno iniziato a porre le basi perla pratica clinica del futuro; nonostante l’entusiasmo degli studi sulle staminali, potrebbe essere sbagliato procedere al trapianto nell’uomo prima del tempo e senza prove consolidate e pubbliche. L’utilità clinica delle staminali potrà essere certa solo se in grado di fornire al paziente strategie sicure, a lungo termine e sostanzialmente più efficaci di qualsiasi altro trattamento disponibile. I riflettori puntati sulle staminali devono portare scienziati, medici, bioeticisti ad agire in modo coordinato, per poter procedere verso un responsabile trasferimento della ricerca sulle staminali in applicazioni cliniche appropriate e basate sull’evidenza.
La ricerca andrebbe indirizzata verso le cellule staminali adulte “ringiovanite”, cioè ricondotte alla pluripotenza della fase embrionale; questa linea di ricerca sarebbe da privilegiare non soltanto per i risultati scientifici che ne potrebbero derivare, ma anche perché consente ai ricercatori di disporre di tante cellule pluripotenti senza dover ricorrere alle cellule staminali dell’embrione umano, la cui utilizzazione per fini di ricerca solleva problemi etici di rilevanza fondamentale.
 Efficienza e servizio, umanità e ricerca, scoperte scientifiche e fede: elementi distinti e differenti che compongono però l'ampio spettro di condizioni e situazioni che un medico oggi deve affrontare nella direzione di un ospedale, nell'assistenza dei propri pazienti e nella ricerca di cure per le malattie di cui soffrono.
Cosa significhi dirigere un ospedale, scontrarsi ogni giorno con il mistero della sofferenza umana, quali siano gli impatti della fede sull'attività scientifica e quali quelli delle scoperte scientifiche sulle proprie credenze, lo abbiamo chiesto in un’intervista al prof. Bruno Dallapiccola, già ordinario di Genetica Medica e oggi Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, responsabile dell'Area di Ricerca Malattie Genetiche e Malattie Rare e membro del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB).
Efficienza e servizio, umanità e ricerca, scoperte scientifiche e fede: elementi distinti e differenti che compongono però l'ampio spettro di condizioni e situazioni che un medico oggi deve affrontare nella direzione di un ospedale, nell'assistenza dei propri pazienti e nella ricerca di cure per le malattie di cui soffrono.
Cosa significhi dirigere un ospedale, scontrarsi ogni giorno con il mistero della sofferenza umana, quali siano gli impatti della fede sull'attività scientifica e quali quelli delle scoperte scientifiche sulle proprie credenze, lo abbiamo chiesto in un’intervista al prof. Bruno Dallapiccola, già ordinario di Genetica Medica e oggi Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, responsabile dell'Area di Ricerca Malattie Genetiche e Malattie Rare e membro del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB).
Professore, da alcuni anni lei guida l’attività scientifica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Potrebbe dirci qual è il suo ricordo più significativo di questi anni?
L’essere riuscito, partendo da una solida realtà esistente, a valutare le eccellenze, mettere nuove regole e, lavorando in trasparenza, a rinvigorire tutto quello che già si svolgeva qui dentro, raddoppiare in cinque anni l'Impact Factor dell'istituto e dunque riorganizzare ciò che necessitava essere messo in ordine. Il Bambino Gesù ha una forza straordinaria dal punto di vista clinico, delle persone di altissimo livello e da quello scientifico. Quindi, con poche leve, è stato possibile ottenere grandi risultati. Questo è il ricordo sicuramente più significativo dell'attività che ho svolto questi anni, una ricetta estremamente semplice che ha avuto però un grande successo."
In un medico o in un operatore sanitario siamo portati a pensare che la fede cristiana influisca sul rapporto con i pazienti. Riflettiamo però meno sul fatto che essa possa influire anche in altri ambiti della sua attività. Potrebbe dirci, professore, se e come la sua fede cristiana ha influenzato il suo modo di fare ricerca scientifica?
"La fede dà una serenità nell'operare, un'indicazione di come ponderare i valori di ciò che si deve fare e, soprattutto, per uno che fa ricerca biomedica, un grande rispetto per la vita e di tutte quelle regole che hanno sicuramente influenzato il mio modo di operare. Aggiungerei poi il senso della gratitudine nei confronti di chi lavora, nel senso di saper privilegiare e premiare chi lavora bene. Il premio può essere anche un riconoscimento pubblico. A me sarebbe piaciuto negli anni, nei vari posti in cui ho lavorato, ricevere anche solo una carezza, un segnale di riconoscimento per il lavoro fatto, non necessariamente un beneficio di tipo economico. Certamente nel mondo della ricerca dove i ricercatori sono mal pagati, anche un beneficio economico va dato, tanto è vero che da tre anni abbiamo instaurato in questo ospedale un sistema premiante per quei ricercatori che superano il valore soglia delle loro attività. Il rispetto dei valori, il saper premiare gli uomini che fanno bene il loro mestiere, avere dei principi guida che ti conducano nel lavoro, sono certamente frutto di una cultura, educazione, formazione cristiana in cui io mi identifico e di cui sono praticante.
Che consiglio si sentirebbe di dare ai giovani che intendono intraprendere il cammino del lavoro universitario e della ricerca scientifica?
"Il primo consiglio che do sempre è rendersi conto che questa in Italia è una strada molto difficile, chi fa il ricercatore oggi in Italia non è assolutamente un privilegiato ma anzi una persona che vive in una condizione estremamente difficile in cui tutto è precario. Io, peraltro, non sono convinto che il ricercatore debba avere un posto per la vita e concordo con la mentalità di tipo americano. Il ricercatore deve aver l'opportunità di mettersi in moto e continuare a mantenere la sua posizione dimostrando la sua bravura. Proprio perché tutto questo definisce il profilo del ricercatore, la sua è una vita particolarmente dura. Bisogna dunque, aver possibilmente rispetto delle passioni, anzi sostenerle, metterle in sintonia con le proprie attitudini e volontà di far ricerca, ma certamente si deve essere consapevoli che la vita è molto dura. Secondo consiglio fondamentale è quello di fare riferimento ad un professore che possa seguire ed orientare il cammino del ricercatore. Queste sono le regole minime per sopravvivere alla ricerca qui oggi, in questo tipo di paese.
 Come medico e genetista di fama internazionale, lei ha potuto accostarsi ad un certo numero di patologie a base genetica, nonché un gran numero di malattie rare. Come medico, come vive la relazione con le persone affette da questo tipo di condizione?
Come medico e genetista di fama internazionale, lei ha potuto accostarsi ad un certo numero di patologie a base genetica, nonché un gran numero di malattie rare. Come medico, come vive la relazione con le persone affette da questo tipo di condizione?
Dei rapporti con i pazienti forse sarebbe meglio chiedere ai pazienti. Nel senso che se hai un buon rapporto con loro in genere sono loro che parlano bene di te. Io credo, in linea di massima, di avere sempre avuto un buon rapporto con i pazienti. Molti miei collaboratori mi hanno ripetuto molte volte che mentre io sono uno che corre molto svolgendo le mie attività, nel momento in cui comincio a fare attività ambulatoriale con i pazienti, mi trasfiguro e dedico loro tutto il tempo di cui hanno bisogno. Il paziente viene, mi pone delle domande e fino a che non ha le risposte a tutte le domande non esce dalla stanza. Naturalmente, l'abitudine a vivere con i malati, i malati rari, i malati che hanno alle spalle una tragedia piccola, media, o grande, mi ha dato una certa abitudine a convivere con le sofferenze umane. Non è che non viva o non mi metta nei panni delle tragedie che incontro, ovviamente provo una compartecipazione, sympatheia, ma cerco comunque di mantenere un certo distacco per non soccombere, dovendo confrontarmi con molte situazioni tragiche ogni giorno. Vivo, sento i problemi dei pazienti, cerco di trovare nei limiti del possibile, le soluzioni, l'adattamento migliore, le risposte che possono essere a ciascuno più congeniali. Una delle regole della consulenza genetica è proprio cercare di aiutare le persone a trovare il miglior adattamento possibile alla loro situazione. In questo senso quindi mi faccio coinvolgere e cerco di trovare delle risposte. Purtroppo, con i limiti delle nostre conoscenze in questo mondo: in quasi due terzi dei casi siamo in grado di dare delle risposte, in un terzo non lo siamo.
Pur contando su risorse di alta eccellenza scientifica e tecnologica, non possiamo mai evitare del tutto il dolore e la sofferenza umana. Cosa ci insegna, a suo parere, l’incontro con il mistero della sofferenza umana?
"Questo incontro secondo me ci aiuta a valorizzare la fede. Poiché soltanto chi ha veramente fede e crede in valori superiori a quelli terreni, riesce a superare i problemi del dolore, della disperazione, delle disgrazie. Per cui, secondo me, sono veramente fortunate le persone che hanno fede e che quindi riescono ad identificare in un valore superiore la possibilità di superare cose che la medicina ufficiale, le situazioni della vita, la contingenza in cui si vive non ti consentirebbero di superare. Purtroppo quella della fede è una ricetta che non tutti hanno, poiché aver fede è frutto di una serie di "fortune" che una persona ha, come quella di crescere in una famiglia in cui sono stati insegnati certi tipi di valori ad esempio. Certe persone, purtroppo, non incontrano la fede perché non hanno avuto la fortuna di incontrare qualcuno che gli abbia insegnato a vivere questi valori superiori; oppure ci sono persone fortunate che riescono comunque a conquistare questi valori in maniera indiretta nel corso della vita. Credo che il riferimento fondamentale, la ricetta "antidolore", non è la pillola che prendi in farmacia, ma è credere in dei valori trascendentali che ti aiutano a vivere il tuo quotidiano."
Alcuni ricercatori, come il genetista statunitense Francis Collins, sono convinti sostenitori che il mondo biologico e della vita rechi con sé un messaggio che lo trascende giungendo a parlare, nel titolo di un suo libro, del DNA come del linguaggio di Dio. A partire dalla sua esperienza, professore, ha mai considerato che l’incontro con il mistero della vita rivelasse in qualche modo l’esistenza di un Creatore?
Il concetto del linguaggio di Dio è stato un argomento tirato fuori nel giugno del 2000 quando è stato sequenziato il genoma umano e, a mio avviso, è impropria come affermazione quella di dire che il sequenziamento del genoma corrisponda alla decodificazione di un linguaggio di Dio. Se fosse così infatti, se il linguaggio di Dio fosse fatto dalle basi del DNA, non lo avrebbe scoperto lui, ma lo avrebbe fatto trent'anni prima Korenberg che aveva identificato il codice genetico. Detto questo, la risposta è che, mentre c'è una parte del mondo della ricerca scientifica che pensa che la scienza possa dare spiegazione a tutto, ce n'è poi un'altra, a mio parere, convinta di come ogni avanzamento della ricerca sposti in là l'asticella e ci consenta di guardare sempre più in alto e pensare che esista un qualcosa che è stato all'inizio di tutto e per chi ha la fede, sicuramente questo non può che essere un Creatore da cui è partito tutto. Francis Collins, che conosco, non è cattolico ma è un uomo di fede e un grande ricercatore. Sicuramente credo di poter condividere il suo modo di vedere: se non si pensa a qualcosa di superiore che governa il mondo e da cui tutto discende, non è possibile spiegare la creazione e tutto il resto che ne è derivato, semplicemente con gli strumenti della nostra ricerca scientifica”.
 Un’enciclica estesa ed esigente come quella che papa Francesco ha firmato con il titolo Laudato si’ in data 24 maggio 2015, non si presta a facili commenti. Innumerevoli i temi che saranno oggetto di analisi, rilanci, osservazioni e, probabilmente, anche di qualche critica. Troppo importanti e delicati gli argomenti trattati per non attendersi un dibattito vivace: dall’opzione per le energie alternative e rinnovabili al valore quasi sacrale di ogni specie biologica; dall’intrinseco legame fra inquinamento e sfruttamento dei poveri alla visione totalmente relazionale, quasi olistica, del rapporto fra uomo e natura; dalla critica alla visione strumentale della tecnica al relativismo come causa della cultura “usa e getta”. È facile che il dibattito che oggi prende ufficialmente avvio (al netto delle anticipazioni di qualche giorno fa), possa condurre a schieramenti e prese di posizione, condizionando la trasmissione di quanto il documento intende, a nostro avviso, comunicare. Una ragione in più per offrirne qui un breve commento. Leggendola si ha l’impressione di non poter restare semplici spettatori, ci si ritrova investiti di una responsabilità che, interpellando il nostro rapporto con gli altri e con la natura, termina interpellando il nostro rapporto con Dio. Siamo invitati a prendere coscienza di avere, tutti, una casa comune; abbiamo un habitat non solo da custodire, ma anche da sviluppare armonicamente e, perché no, da contemplare, da valorizzare, di cui gioire con sobrietà e umiltà. È come se papa Bergoglio ci facesse salire su un vettore spaziale e, come accadde decenni or sono agli astronauti della missione Apollo 8, ci mostrasse per la prima volta il nostro pianeta azzurro con una nuova profondità di campo. Al vederlo con questa nuova prospettiva, simile a quella che ebbero gli astronauti nel Natale del 1968 dall'orbita lunare, ne cogliamo la fragilità e la sua condizione di casa comune, lo riconosciamo come origine solidale del genere umano che lo abita. Una percezione che —proprio come chi, dallo spazio, riflette sulla posizione della terra e dell’uomo nel cosmo— dovrebbe spingere anche ciascuno di noi a cercare nella comune dipendenza da un Creatore, un fondamento che motivi il nostro agire responsabile, una base su cui edificare un futuro più ottimista, una volta convertiti a comportamenti che pongono al centro il rispetto degli altri, il servizio, la condivisione.
Un’enciclica estesa ed esigente come quella che papa Francesco ha firmato con il titolo Laudato si’ in data 24 maggio 2015, non si presta a facili commenti. Innumerevoli i temi che saranno oggetto di analisi, rilanci, osservazioni e, probabilmente, anche di qualche critica. Troppo importanti e delicati gli argomenti trattati per non attendersi un dibattito vivace: dall’opzione per le energie alternative e rinnovabili al valore quasi sacrale di ogni specie biologica; dall’intrinseco legame fra inquinamento e sfruttamento dei poveri alla visione totalmente relazionale, quasi olistica, del rapporto fra uomo e natura; dalla critica alla visione strumentale della tecnica al relativismo come causa della cultura “usa e getta”. È facile che il dibattito che oggi prende ufficialmente avvio (al netto delle anticipazioni di qualche giorno fa), possa condurre a schieramenti e prese di posizione, condizionando la trasmissione di quanto il documento intende, a nostro avviso, comunicare. Una ragione in più per offrirne qui un breve commento. Leggendola si ha l’impressione di non poter restare semplici spettatori, ci si ritrova investiti di una responsabilità che, interpellando il nostro rapporto con gli altri e con la natura, termina interpellando il nostro rapporto con Dio. Siamo invitati a prendere coscienza di avere, tutti, una casa comune; abbiamo un habitat non solo da custodire, ma anche da sviluppare armonicamente e, perché no, da contemplare, da valorizzare, di cui gioire con sobrietà e umiltà. È come se papa Bergoglio ci facesse salire su un vettore spaziale e, come accadde decenni or sono agli astronauti della missione Apollo 8, ci mostrasse per la prima volta il nostro pianeta azzurro con una nuova profondità di campo. Al vederlo con questa nuova prospettiva, simile a quella che ebbero gli astronauti nel Natale del 1968 dall'orbita lunare, ne cogliamo la fragilità e la sua condizione di casa comune, lo riconosciamo come origine solidale del genere umano che lo abita. Una percezione che —proprio come chi, dallo spazio, riflette sulla posizione della terra e dell’uomo nel cosmo— dovrebbe spingere anche ciascuno di noi a cercare nella comune dipendenza da un Creatore, un fondamento che motivi il nostro agire responsabile, una base su cui edificare un futuro più ottimista, una volta convertiti a comportamenti che pongono al centro il rispetto degli altri, il servizio, la condivisione.
Qual è, dunque, il messaggio centrale dell’enciclica? Un documento, questo, di intelaiatura certamente cristologica, come ben dimostra la sezione biblica, nella quale troviamo una coraggiosa ma certamente opportuna citazione di Teilhard de Chardin (cf. n. 83), un testo per la cui stesura il Papa ha scelto come fonti spirituali privilegiate san Francesco e san Bonaventura e come falsariga per gli aspetti filosofici il noto saggio di Romano Guardini La fine dell’epoca moderna (1950). Riteniamo che il cuore del messaggio sia chiarire, in modo articolato e motivato, il valore morale e relazionale di ogni nostra azione, per piccola che possa sembrare. Dalle grandi multinazionali alla madre di famiglia, dai politici agli imprenditori, da chi muove le leve dell’industria a chi decide le strategie economiche dei Paesi, uomini potenti e uomini comuni, tutti siamo invitati a riflettere sulle conseguenze dei nostri comportamenti, perché essi non sono mai privati, neutri: su un pianeta come il nostro ogni gesto entra in relazione con gli altri, edifica o distrugge, conserva o spreca, valorizza o umilia, custodisce o trascura. La valenza morale del nostro essere parte di un’umanità che abita la terra, però, non riguarda solo il fatto di dover evitare comportamenti dannosi e irresponsabili: la vita morale alla quale siamo consapevolmente invitati riguarda anche la gratitudine per esserci, la contemplazione del creato che ci circonda, la gioia di riconoscersi al centro di una trama di relazioni che ci precede e ci accompagna e che ha la sua origine più radicale nella volontà amorosa di un Creatore. Il testo di papa Bergoglio, in sostanza, si dirige in modo chiaro ed energico contro l’individualismo, ma non si esaurisce per questo in una condanna: è l’invito a rispettare quanto abbiamo ricevuto e a costruire insieme una creazione ancora in status viae. «Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo —ci esorta papa Francesco— i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati» (n. 11). L’uomo, ci viene ricordato, non è solo libertà, ma anche natura e lo spreco è proprio di chi non riconosce nessuno sopra di sé (cf. n. 6). In definitiva, ambiente umano e ambiente naturale, valore della vita umana e valore che diamo alla natura, crescono o degradano insieme (cf. n. 48).
I canoni del rapporto fra uomo e natura richiedono una necessaria relazione con il Creatore: non possiamo difendere la terra in una logica in cui l’essere umano debba scomparire per fare posto alla natura; non custodiamo la natura per onorare la natura, ma perché la natura è creatura di Dio, insieme all’uomo ed in certa misura a lui ordinata. Sufficientemente chiare paiono, in tal senso, le seguenti parole: «Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una riduzione della natalità. Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di “salute riproduttiva”. Però, “se è vero che l’ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse disponibili crea ostacoli allo sviluppo e ad un uso sostenibile dell’ambiente, va riconosciuto che la crescita demografica è pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale” [Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 483]. Incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi» (n. 50). La Chiesa ricorda non solo il dovere di prendersi cura della natura, ma anche, e soprattutto, quello di proteggere l’uomo contro la distruzione di sé stesso (cf. n. 79).
 La proposta che soggiace il documento è quella di porre le basi perché si possa parlare di una ecologia integrale. L’espressione non si riferisce tanto al fatto di estendere l’oggetto materiale delle nostre cure per includervi sempre nuovi elementi o comportamenti, quanto all’idea di generare una cultura —ed una corrispondente leadership— capace di accrescere in noi la consapevolezza del valore delle relazioni che ci legano agli altri, alla natura, a Dio, l’importanza di ciascuna di esse per il bene del tutto. In tal senso, si può parlare di una vera e propria “ecologia culturale”: «Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale. Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più ampio. In modo più diretto, chiede di prestare attenzione alle culture locali nel momento in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare» (n. 143). Ne viene così rivista la nozione di “qualità della vita”: essa non è più solo legata ai beni materiali e di consumo di cui si dispone, ma alle relazioni di cui si è protagonisti; relazioni storiche, familiari, culturali, ambientali che ci arricchiscono e ci fanno essere noi stessi (cf. n. 145). Si trova qui un’importante ermeneutica di tutto il documento: quando parliamo di “ambiente”, afferma papa Francesco, facciamo riferimento alla relazione tra la natura e la società che la abita (cf. n. 139). Aspetto fondamentale di questa ecologia integrale è riflettere sulla nozione di “ecologia umana” che, in continuità con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Francesco non teme di collegare all’idea di natura umana e di legge naturale. L’ecologia umana, si afferma, implica la necessaria relazione della vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella propria natura, indispensabile per creare un ambiente dignitoso e vivibile, nel quale l’essere umano si trovi a proprio agio. Ed esiste una “ecologia dell’uomo” perché anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere (cf. n. 155; Benedetto XVI, Discorso al Deutscher Bundestag, Berlino, 22.9.2011). Non mancano qui delle applicazioni al problema del gender: «Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda di cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa» (n. 155).
La proposta che soggiace il documento è quella di porre le basi perché si possa parlare di una ecologia integrale. L’espressione non si riferisce tanto al fatto di estendere l’oggetto materiale delle nostre cure per includervi sempre nuovi elementi o comportamenti, quanto all’idea di generare una cultura —ed una corrispondente leadership— capace di accrescere in noi la consapevolezza del valore delle relazioni che ci legano agli altri, alla natura, a Dio, l’importanza di ciascuna di esse per il bene del tutto. In tal senso, si può parlare di una vera e propria “ecologia culturale”: «Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale. Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più ampio. In modo più diretto, chiede di prestare attenzione alle culture locali nel momento in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare» (n. 143). Ne viene così rivista la nozione di “qualità della vita”: essa non è più solo legata ai beni materiali e di consumo di cui si dispone, ma alle relazioni di cui si è protagonisti; relazioni storiche, familiari, culturali, ambientali che ci arricchiscono e ci fanno essere noi stessi (cf. n. 145). Si trova qui un’importante ermeneutica di tutto il documento: quando parliamo di “ambiente”, afferma papa Francesco, facciamo riferimento alla relazione tra la natura e la società che la abita (cf. n. 139). Aspetto fondamentale di questa ecologia integrale è riflettere sulla nozione di “ecologia umana” che, in continuità con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Francesco non teme di collegare all’idea di natura umana e di legge naturale. L’ecologia umana, si afferma, implica la necessaria relazione della vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella propria natura, indispensabile per creare un ambiente dignitoso e vivibile, nel quale l’essere umano si trovi a proprio agio. Ed esiste una “ecologia dell’uomo” perché anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere (cf. n. 155; Benedetto XVI, Discorso al Deutscher Bundestag, Berlino, 22.9.2011). Non mancano qui delle applicazioni al problema del gender: «Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda di cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa» (n. 155).
Nella situazione odierna, la nozione di bene comune non può essere impiegata senza far riferimento anche ad un “principio di solidarietà” (cf. nn. 155-158). Parlare di ambiente si traduce dunque, necessariamente, in un discorso sull’attenzione ai più poveri, che dei comportamenti contrari ad una retta ecologia sono i primi a pagarne le conseguenze. Siamo dunque di fronte ad un documento di dottrina sociale della Chiesa, nel quale il tema della giustizia, dell’equa distribuzione dei beni e della difesa dei più deboli costituisce la maggiore preoccupazione di fondo che ne motiva le riflessioni. Sarebbe però riduttivo inquadrarla come una semplice enciclica sociale, così come sarebbe riduttivo, per quanto prima visto, interpretare la nozione di ecologia come semplice cura dell’ambiente naturale. La trama di relazioni da curare e da sanare è assai più profonda e complessa di quella messa in luce da una semplice riflessione sulla natura e sui suoi dinamismi conseguenti le azioni dell’uomo. L’enciclica ci pone di fronte anche ad una visione della scienza e della tecnica, ai loro rapporti e, soprattutto, al ruolo dell’uomo come soggetto dell’impresa tecnico-scientifica.
Scienza e religione, pur fornendo approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produttivo (cf. n. 62); anzi, per costruire un’ecologia che permetta di riparare ciò che abbiamo distrutto, nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata (cf. n. 63). Una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, deve tener conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica sociale (cf. n. 110). Papa Francesco, come già prima di lui Giovanni Paolo II, prende le distanze da una visione della neutralità della scienza o della tecnica. Esse sono azioni dell’uomo e, dunque, legate ad una specifica valutazione morale. «Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare» (n. 107) La tecnologia comporta certamente dei rischi, ma non va demonizzata, perché ad essa dobbiamo il miglioramento delle nostre condizioni di vita (cf. nn. 103-104). Affinché la scienza e la tecnica cooperino al bene e al progresso umano sono necessarie due cose: lo studio e la trasformazione della realtà devono rispettare la verità e il significato presenti nelle cose, ultimamente poggiato su una relazione di creazione (cf. n. 117); inoltre, l’operatore scientifico deve crescere in umanità e saggezza. Ritroviamo quanto Guardini stesso aveva indicato sia ne La fine dell’epoca moderna, più volte citata da papa Francesco, sia nel saggio Lettere dal Lago di Como (1925) a proposito delle necessità di una valorizzazione umanistica della tecnica. «L’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza, perché l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza» (n. 105). Il potere va orientato al servizio, la singolarità dell’uomo nella natura va ordinata alla capitalità di Cristo sulla creazione. «Non è possibile frenare la creatività umana. Se non si può proibire a un artista di esprimere la sua capacità creativa, neppure si possono ostacolare coloro che possiedono doni speciali per lo sviluppo scientifico e tecnologico, le cui capacità sono state donate da Dio per il servizio degli altri. Nello stesso tempo, non si può fare a meno di riconsiderare gli obiettivi, gli effetti, il contesto e i limiti etici di tale attività umana che è una forma di potere con grandi rischi» (n. 131).
Sempre in merito al rapporto con le scienze, alcuni spiriti critici potranno forse distanziarsi da alcune affermazioni del testo le quali, se prese letteralmente, potrebbero risultare non sempre precise. Ad esempio, l’idea che si debba lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione (cf. 89), se presa in senso letterale, sembrerebbe ignorare che, in un quadro evolutivo, la maggior parte delle specie biologiche si estinguono necessariamente per dare origine a morfologie maggiormente in sintonia con l’ambiente, e che la comparsa della specie umana si è necessariamente giovata proprio di tali estinzioni. In realtà, così ci sembra, l’enciclica vuole sottolineare che ogni vivente —passato, presente o futuro— partecipa della sacralità della vita, che ha in Dio la sua fonte; pertanto, ogni specie biologica merita rispetto e tributa lode al Creatore. L’idea che il comportamento umano sia all’origine di vere e proprie catastrofi naturali (cf. 161) potrebbe sorprendere qualcuno, ma il Pontefice, così ci sembra, pare riferirsi ad una tipologia piuttosto ampia di danni, che non andrebbe sempre identificata con sconvolgimenti geologici di grande scala. Il fatto, poi, che esista un consenso della maggior parte degli scienziati circa la realtà del riscaldamento globale (nn. 23, 51), potrebbe risultare a qualcuno non condivisibile, ma è un dato oggettivo che tale capitolo sia stato, e continui ad essere, all’ordine del giorno di Conferenze internazionali dove gli uomini di scienza sono ascoltati e possono confrontarsi fra loro. L’opzione espressa, infine, in favore delle energie alternative e rinnovabili da preferire ai combustibili fossili (n. 165) potrebbe forse non tener conto che, allo stadio attuale, tali energie non sempre implicano dei cicli meno inquinanti, ma resta pur sempre vero che la direzione verso la quale muoversi non potrà essere che quella.
«In questa Enciclica, afferma papa Francesco, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune» (n. 3). La custodia del pianeta, ma anche la cura e lo sviluppo del tessuto di relazioni antropologiche, storiche e culturali associate alla nozione di “ecologia integrale”, è vista dal Pontefice come un fecondo terreno di incontro per diversi popoli e culture, una preziosa occasione di dialogo per le religioni che si riconoscono interpreti di un principio di creazione, il tema-guida di un ecumenismo su larga scala che aiuti l’uomo a riprendere coscienza del suo ruolo e del suo destino. L’educazione alla sobrietà, all’umiltà e alla pace coinvolge davvero tutti e a tutti interessa. In un mondo frammentato, ove l’individualismo e il materialismo rischiano di appiattire ciò che l’essere umano è, per natura, nel panorama della creazione, il comune dialogo sull’ambiente, ambiente naturale ed ambiente umano, diviene cruciale. Può essere un nuovo punto di partenza —così ce lo auguriamo— per tornare a guardare il nostro pianeta azzurro con la prospettiva giusta: non solo il luogo di risorse che devono essere ottimizzate e di spazi da condividere, ma anche come il luogo che custodisce la memoria di un dono del Creatore, quella della vita di ciascun essere umano, di ogni vivente che ci ha preceduto e che verrà.
© 2015 Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede
Parlare di Expo Milano 2015 vuol dire ormai avviarsi a delineare un bilancio dell’evento, che terminerà a fine ottobre: impresa difficile, tante sono le valenze di questi sei mesi ininterrotti della manifestazione internazionale. Ha primeggiato (ma forse avrebbe dovuto avere ancor più attenzione) il tema centrale, “nutrire il Pianeta”; ma c’è tutta una costellazione di temi connessi: salvaguardia dell’ambiente, questione energetica, equità nei commerci, geopolitica; e non sono da meno gli aspetti legati alla socialità e alle culture: accoglienza, multietnicità, incontro di tradizioni, bellezza.
Non è questa la sede, e non abbiamo neppure gli strumenti, per tracciare valutazioni complessive e tanto meno quantitative (anche se i numeri pare stiano dando ragione agli expottimisti); però ci sembra di intravvedere un elemento prezioso fare capolino tra la congerie di proposte, appuntamenti, convegni, ruotanti attorno ai padiglioni (spettacolari) del sito di Rho-Pero e nelle numerose iniziative del fuori-Expo. Un elemento che forse molti dei visitatori non hanno colto con chiarezza, troppo colpiti dalla imponenza dell’evento e attratti (o meglio, distratti) dalla pluralità e contemporaneità di richiami e suggestioni, che poco spazio lascia alla riflessione sui messaggi e alla assimilazione dei contenuti, da quelli più tecnici e descrittivi a quelli più profondi e meno espliciti.
Ecco a cosa ci riferiamo. Quello di nutrire il Pianeta è un problema serio e urgente, che è da sempre nelle agende dei vari programmi di sviluppo internazionali e non riesce a passare nel catalogo dei “problemi risolti”. Lo aveva evidenziato Papa Francesco in febbraio nel videomessaggio inviato in occasione dell’evento "Le Idee di Expo 2015", richiamando quello che già san Giovanni Paolo II indicava come "paradosso dell'abbondanza": «c'è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e l'uso di alimenti per altri fini sono davanti ai nostri occhi. Questo è il paradosso! Purtroppo questo paradosso continua a essere attuale».
Questa situazione, come in genere le diverse crisi ambientali - dalle varie forme di inquinamento, alla desertificazione, al dissesto idrogeologico - sono l’espressione macroscopica e drammatica di qualcosa che avviene o è avvenuto più in profondità; affondano le radici in qualcosa che non coinvolge soltanto i meccanismi e gli equilibri naturali ma tocca direttamente l’uomo. La radice sta in quello che, nella Centesimus Annus, il Papa polacco aveva definito “errore antropologico”: «L'uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui».
È lo stesso giudizio che ha portato Papa Francesco a parlare, nella Laudato si, di “antropocentrismo deviato”, figlio del relativismo pratico e «ancora più pericoloso di quello dottrinale», generatore di «uno stile di vita deviato» e di una logica «usa e getta che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno».
Quella che balza subito in primo piano di fronte al tema della fame allora è la domanda sull’uomo, sul suo modo di rispondere ai suoi bisogni, sul modo con cui imposta le sue relazioni: con la natura, con gli altri, con Dio. C’è un evidente legame tra cibo e idea di uomo e di umanità. Nella Carta di Milano – il documento programmatico sottoscritto dai partecipanti a Expo – si dichiara: “il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e i suoi abitanti”. Se al centro c’è l’uomo, secondo un giusto antropocentrismo che rifugga gli estremi sia di una sottovalutazione della natura sia della sua esaltazione panteistica, allora i valori materiali e quelli simbolici possono andare insieme e i secondi non si ridurranno a un’appendice estetica o moralistica tutto sommato superflua.
Del resto, il titolo stesso della manifestazione milanese si presta a una lettura più ampia e integrale: quella che potrebbe sembrare una pura aggiunta - “energia per la vita” - sta a indicare che “nutrire il pianeta” non è solo una questione alimentare e che ciò di cui abbiamo bisogno è di tutto quello che può “nutrire la vita”. La difficoltà di molti protagonisti di Expo a declinare il tema in questo modo ampio, come pure la resistenza di molti visitatori a leggere così le diverse proposte è dipesa, oltre che da una mancanza di coraggio culturale, da una visione riduttiva del termine “vita”. Laddove ciò non è avvenuto, la vista a Expo è risultata maggiormente interessante e coinvolgente. A partire dal Padiglione Zero, che ha invitato a guardare il Pianeta dall’interno, sotto la crosta terrestre ripercorrendo, attraverso i simboli e le mitologie, le fasi dell’evoluzione del rapporto dell’uomo con la Natura fino alle forti contraddizioni dell’alimentazione contemporanea. Ma anche lo spazio della Santa Sede, “Non di solo pane”, ha offerto suggestioni di grande intensità, sottolineando come “Il cibo e l’azione del nutrire sono per l’uomo uno spazio di educazione senza paragone e senza precedenti, vista la forza e l’universalità delle loro dinamiche simboliche”; e raccontando, in un originale tavolo interattivo, le diverse connotazioni di un luogo che unisce tanti momenti della vita umana, un luogo che è mensa, altare, scrivania, banco di lavorazione.
In altri casi ci sono stati interessanti richiami alle culture e alle tradizioni locali, in vario modo connessi alla tematica alimentare. A volte questo può essere scaduto in azione turistica e promozionale; ma complessivamente il visitatore attento ha potuto, e può ancora in questo scampolo di esposizione, percepire il messaggio di un nesso fondamentale tra visione dell’uomo e problema alimentare, di una unitarietà tra coltura e cultura. Si può estendere alla questione alimentare quello che Benedetto XVI aveva detto riferendosi al problema dell’acqua nel messaggio per l’esposizione internazionale di Saragozza del 2008: “Il fatto che oggigiorno si consideri l'acqua come un bene preminentemente materiale, non deve far dimenticare i significati religiosi che l'umanità credente, e soprattutto il cristianesimo, ha sviluppato a partire da essa, dandole un grande valore come un prezioso bene immateriale, che arricchisce sempre la vita dell'uomo su questa terra. (…) Il pieno recupero di questa dimensione spirituale è garanzia e presupposto per un'adeguata impostazione dei problemi etici, politici ed economici che condizionano la complessa gestione dell'acqua da parte di tanti soggetti interessati, nell'ambito sia nazionale sia internazionale”.
In questa linea si situano gli elementi propositivi che ci pare di aver colto e che possono rappresentare una componente cospicua dell’eredità di Expo: non alternativa all’eredità di decisioni e iniziative sociali, economiche e politiche ma necessaria per dare “nutrimento” e solidità a tali iniziative. E comunque dovrà essere fattore centrale di quel lavoro educativo che è l’unica condizione perché il dopo-Expo non si riduca a una raccolta di ricordi o alla riproposizione di spettacolari reportage multimediali ma diventi possibilità di costruzione di soggetti maturi e consapevoli, trovando educatori – come auspica l’Enciclica Laudato si – “capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione”.
Ho il piacere di vivere ad Oxford da molti anni e posso dire che è una città unica nel suo genere in Inghilterra. La città sembra costruita per avere l’università nel suo cuore, i colleges sono ovunque con magnifiche architetture che in molti casi risalgono a centinaia di anni fa. Passeggiare nel centro di Oxford, specialmente di notte, quando ci sono poche persone in giro, è come viaggiare indietro nel tempo fino al medioevo e alla prima modernità.
Io sono uno scienziato, lavoro nel campo delle scienze farmaceutiche, ma ad Oxford ho avuto la possibilità di conoscere un po’ di filosofia e teologia frequentando seminari serali offerti a studenti. Inoltre ho potuto seguire alcuni corsi presso un collegio di frati domenicani: anche se Tommaso d’Aquino visse nel medioevo ho potuto verificare quanto i suoi insegnamenti possano ancora essere attuali.
Nel mondo accademico anglosassone è comune assistere a dibattiti su temi riguardanti il rapporto tra scienza e fede. Vengono organizzate molte conferenze presso diversi college, in particolare presso il centro Ian Ramsey per la scienza e la religione.
La mia impressione è che nel mondo accademico britannico si tenda a ritenere scienza e fede come opposte e in conflitto. Un esempio calzante sono i dibattiti di Richard Dawkins con Alister McGrath e Rowan Williams, tutti liberamente visualizzabili su Youtube. Questa modalità di impostare il dibattito tra scienza e fede è molto differente dal lavoro interdisciplinare che stanno portando avanti altre istituzioni e realtà culturali, come la stessa Sisri.
Nel dibattiti che caratterizzano il mondo anglosassone, spesso gli accademici che vogliono mostrare come il loro approccio scientifico sia l’unico corretto per acquisire conoscenza, combattono contro ciò che ritengono essere l’approccio irrazionalista adottato dalle religioni. Rivendicano infatti che la realtà può essere descritta solo usando inferenze razionali, usando un mix di metodi deduttivi, abduttivi, induttivi, logico-matematici. Richard Dawkins è probabilmente l’intellettuale più famoso in questa linea di pensiero.
Ma non tutti nel mondo britannico si riconoscono in questa impostazione culturale, occorre infatti ricordare che l’Inghilterra è una nazione cristiana dove il monarca è ancora il capo della chiesa d’Inghilterra e molti intellettuali vedono nelle posizioni degli scienziati atei un rischio per l’estrema secolarizzazione della società. Dunque non è sorprendente trovare accademici intenti a praticare apologetica cristiana.
Nei dibattiti inglesi ho visto all’opera due strategie diverse di risposta alle rivendicazioni anti-religiose degli scienziati atei: un approccio è mostrare che fede e scienza condividono un medesimo metodo conoscitivo, l’altro approccio invece accetta il contrasto tra metodi della scienza e conoscenza per fede, ma nega che questo sia un problema.
Il primo approccio è stato ben presentato dal professor McGrath, il quale ha cercato di mostrare che la religione è ragionevole in quanto alla teologia possono essere applicati il metodo e i canoni della scienza. Un altro accademico di Oxford che segue un approccio simile è il professor Richard Swinburne: questo filosofo è convinto che la verità del cristianesimo possa essere mostrata dal fatto che l’esistenza di Dio è altamente probabile. Comunque questo approccio non riesce a dire molto sulla natura di Dio e non può giustificare l’esistenza di nessun contenuto dottrinale.
Il secondo approccio è portato avanti dal professor Tom Simpson, un altro filosofo di Oxford. Su Youtube si può vedere un suo seminario tenuto presso il centro Ian Ramsey e intitolato “The nature of scientific and religious belief”. Il professor Simpson accetta l’uso dell’inferenza razionale come il metodo corretto per lo sviluppo della conoscenza nelle scienze naturali, invece il credo religioso è razionalmente valutabile in base alle norme di testimonianza. In altre parole le religioni rivelate invitano alla credenza sulla base della testimonianza, piuttosto che sulla base dell’inferenza razionale.
Ci sono dunque cinque vie della conoscenza: le percezioni, la memoria, l’inferenza razionale, l’introspezione, la testimonianza. La via della conoscenza per i credenti nelle religioni rivelate è basata sulla testimonianza e non sull’inferenza razionale, la quale è usata dalle scienze naturali. Provare ad assimilare il credo religioso alle categorie di inferenza razionale è dunque un errore, dal momento che l’informazione religiosa è trasmessa attraverso la testimonianza.
Usando questo approccio l’esistenza di molti contenuti dottrinali può essere spiegata e acquisisce di senso. Il professor Simpson ritiene che vi sono due requisiti essenziali richiesti per acquisire conoscenza tramite testimonianza. Infatti quando qualcuno ci dice qualcosa noi inconsciamente ci chiediamo:
- questa persona conosce ciò di cui parla?
- questa persona mente o è veritiera?
Se noi siamo sicuri che la persona è onesta e ha autorità epistemica su ciò che dice, allora noi crediamo che l’informazione comunicata è vera e costituisce conoscenza.
Lo stesso ragionamento può essere applicato alla religione rivelata nella comunità dei fedeli. In questo caso comune responsabilità epistemiche sono trasmesse attraverso le istituzioni e le norme della comunità credente.
Ma è importante anche sottolineare che anche nelle scienze naturali la testimonianza gioca un fattore importante come vettore di trasmissione di conoscenze. Per esempio, quando uno scienziato presenta alcune scoperte in una conferenza, l’auditorio crede che i risultati degli esperimenti siano reali e non inventati, non avendo di certo la possibilità di verificare in tempo reale le dichiarazioni dello scienziato. A questo proposito qualche anno fa si scoprì che un professore di genetica sud coreano aveva falsificato i dati delle sue ricerche per lungo tempo. Dal momento che erano stati pubblicati da una prestigiosa rivista scientifica erano stati ritenuti validi. La successiva scoperta della truffa fu un serio danno all’immagine del rigore della ricerca scientifica.
Un altro interessante esempio è dato dall’utilizzo di prove assistite dal computer: molte operazioni matematiche sono troppo complesse per essere effettuate manualmente e vengono affidate a computer. I matematici accettano i risultati del computer fidandosi che l’algoritmo di risoluzione del computer non sbagli, senza ricontrollare tutti i calcoli.
Dunque possiamo concludere che ogni persona decide di acquisire conoscenza attraverso la testimonianza di un’altra persona o di un’istituzione solo se queste sono considerate sincere e in possesso di autorità epistemica. Probabilmente potremmo andare anche al di là dell’approccio del professor Simpson non contrapponendo rigidamente inferenza razionale e testimonianza. Come vediamo entrambe all’opera nel lavoro scientifico, non escludiamo che entrambe si possano parimenti trovare nell’esperienza religiosa.
Ovviamente quanto ho appena proposto non vuole essere una spiegazione risolutiva di ciò che è fede e scienza, ma solo una descrizione di come il dibattito tra le due visioni, scientifica e religiosa, venga impostato nel mondo accademico anglosassone e quali strategie concettuali vengano adottate per affrontarlo.
Nel mondo di oggi si può parlare di tanti tipi di disuguaglianze. Partendo da considerazioni di ordine prettamente economico si può parlare della disuguaglianza tra tenori di vita, distinguendo due tipi di tali disuguaglianze: quella mondiale (tra paesi) e quella all’interno dei paesi. Innanzitutto è chiaro che quando si dice ad esempio che il 10% più povero ha un tenore di vita pari a un decimo del 10% dei più ricchi non ha lo stesso significato in India e in Svizzera. Conviene allora aggiungere una regola generale , meno relativa, quando si valuta la disuguaglianza: stabilire una soglia assoluta di povertà e il valore più utilizzato oggi è quello di circa un euro al giorno pro capite.
Qual è l’evoluzione della disuguaglianza tra i tenori di vita? Ebbene, sta avvenendo una doppia inversione di tendenza: da un lato, parlando della disuguaglianza tra stati, dopo un secolo di continuo aumento, la disuguaglianza tra stati da vent’anni a questa parte ha iniziato a diminuire: se nel 1989 il tenore di vita in Francia e in Germania era di venti volte superiore a quello della Cina o dell’India, ora tale divario si è dimezzato. D’altra parte la disuguaglianza all’interno di molti paesi è invece andata aumentando, dopo un lungo periodo stazionario. Quindi dobbiamo sempre metterci d’accordo su quale tipo di disuguaglianza stiamo parlando.
Una spiegazione della diminuzione della disuguaglianza tra stati negli ultimi 20 anni è dovuta alla innovazione tecnologica, al miglioramento dell’istruzione, alla formazione della manodopera, alle conoscenze tecniche e scientifiche. Anche se i paesi meno sviluppati non possiedono tutte le tecnologie dei paesi sviluppati, è come però se questi ultimi si trovassero sulla frontiera tecnologica e crescano assieme a questa, mentre i paesi in via di sviluppo si trovassero al di qua della frontiera e la loro crescita è dovuta alla capacità di adattare la propria situazione alle tecnologie e all’organizzazione economica osservati nei paesi sviluppati. Naturalmente non tutti i paesi in via di sviluppo stanno conoscendo questo processo di crescita.
Per quanto riguarda l’altro tipo di disuguaglianza, quella all’interno dei singoli stati, questa è leggermente aumentata nel corso del 19° secolo, per poi ridursi notevolmente tra la prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra. La realizzazione di grandi sistemi di redistribuzione e anche l’egualitarismo imposto dalle rivoluzioni russa e cinese sui propri territori ha ridotto infatti tale disuguaglianza nella maggior parte dei paesi sviluppati. Poi c’è stato uno stallo fino alla fine degli anni ottanta, e da questo momento la disuguaglianza interna agli stati è andata aumentando: siamo sempre sotto il livello medio precedente alla prima guerra mondiale, ma comunque aumenta. Quindi lo sviluppo dei paesi emergenti e, in misura minore, di quelli in via di sviluppo contribuisce a ridurre la disparità tra i tenori di vita degli abitanti dell’intero pianeta, ma l’aumento delle disuguaglianze interne tende, al contrario, ad aumentarla. Oggi come oggi la prima tendenza prevale sulla seconda, e quindi la disuguaglianza globale è in diminuzione, ma non è detto che sarà sempre così.
Dato che il problema delle disuguaglianze è abbastanza uniforme, è difficile non collegarlo a cause comuni, e in particolare alla globalizzazione.
Innanzitutto vediamo di definire il termine di globalizzazione. Sembra una domanda ingenua, dato che questo termine ha ormai invaso al nostra vita e tutti più o meno sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma in realtà la risposta a questa domanda è assai complessa, tanto che è molto difficile darne sia una definizione sia una descrizione. Alcuni elementi caratteristici della globalizzazione sono ad esempio:
1) La formazione di un mercato finanziario globale: le tecnologie della comunicazione consentono il trasferimento in pochi secondi di enormi capitali da un continente all’altro. L’informazione non ha limiti, quindi la crisi della borsa di un paese si riflette, nel giro di pochi minuti sulle borse degli altri paesi. Il termine “villaggio globale”, che ormai è di uso comune, esprime bene la velocità e la diffusione della comunicazione nel mondo, per cui le notizie e le conoscenze non sono più ristrette a un numero limitato di individui ma diffuse e condivise in tutto il globo.
2) Il potere della conoscenza delle tecnologie: le innovazioni tecnologiche non sono più necessariamente nei beni e nei servizi scambiati, ma sono incorporate nelle menti degli individui. In altre parole, per trarre vantaggio, in termini tecnico-scientifici, dalla conoscenza, occorre aver superato una determinata soglia di sapere, in modo da poter dialogare con tale conoscenza.
3) Iperconcorrenza: la legge della competitività portata alle estreme conseguenze.
4) Perdita di rilevanza dello stato o del sistema nazionale.
5) Formazione di una cultura globale.
La globalizzazione si rivela come un fenomeno ambivalente: c’è chi la mitizza e ne mette in luce gli aspetti positivi, e chi la demonizza, pensandola causa di tanti mali. Di sicuro la globalizzazione ha ridotto il livello di disuguaglianza tra paesi, facendo uscire centinaia di milioni di persone dalla soglia di povertà. All’interno dei paesi ha invece contribuito direttamente o indirettamente ad un suo aumento: infatti attraverso la globalizzazione viene diminuita la remunerazione relativa del lavoro scarsamente qualificato, che subisce la concorrenza diretta della manodopera a buon mercato delle economie emergenti, e vengono aumentati i profitti del capitale e del lavoro altamente qualificato. I contrari alla globalizzazione quindi ritengono che la globalizzazione sia un fenomeno che impoverisce ancora di più i già poveri e arricchisce ancora di più i ricchi.
Dal punto di vista strettamente economico ci sono varie domande, che io lascio come quesiti, (nel libro La globalizzazione della disuguaglianza l’economista François Bourguignon cerca di fornire alcune risposte). In questo “scontro” tra diminuzione delle disuguaglianze tra paesi e aumento di quelle all’interno dei paesi, si deve “lasciar fare” al tempo e stare a guardare come si svilupperà questo scontro? E poi la disuguaglianza interna in aumento sarà il prezzo da pagare perché le economie nazionali si sviluppino efficacemente in un mondo globalizzato?
Infine c’è la questione relativa alla relazione tra disuguaglianze (o uguaglianza) ed efficienza economica. Cosa deve intendersi per efficienza in economia? Secondo alcuni economisti, si dice efficiente una situazione in cui non è possibile aumentare il benessere di un soggetto senza diminuire quello di un altro. Di sicuro, troppa disuguaglianza ostacola il funzionamento dell’economia. Ad esempio, quando in una nazione ci sono alunni dotati che però non hanno accesso all’istruzione superiore perché le loro famiglie non possono permetterselo, e viceversa vanno all’università ragazzi anche non particolarmente dotati, nati in ambienti privilegiati: questo è un caso di economia non efficiente. Così, ad esempio, uno stato in cui c’è una violenza endemica non potrà avere un’economia efficiente perché la popolazione e lo stato saranno costretti a destinare gran parte del loro bilancio alla sicurezza.
François Bourguignon conclude il saggio già citato dicendo che in questo contesto un dato positivo è la comparsa di una coscienza mondiale del legame che collega globalizzazione e disuguaglianze. E’ verosimile che la disuguaglianza continuerà a diminuire ancora per un lungo periodo, soprattutto se si ha la volontà di accelerare la crescita dei paesi più poveri. Allo stato attuale sarebbe sufficiente che i paesi sviluppati ed emergenti fossero in grado di controllare l’incremento delle disuguaglianze interne alle proprie economie per fermare la globalizzazione della disuguaglianza conservando al contempo i lati positivi della globalizzazione. Ne hanno la capacità, ma ne hanno la volontà? In realtà la lotta alle disuguaglianze deve diventare impresa comune, invece che l’iniziativa di paesi isolati. Evitare la globalizzazione della disuguaglianza passa attraverso una globalizzazione della redistribuzione che non può rimanere compito dei singoli paesi.
Proprio perché ci troviamo in un mondo globalizzato, in un villaggio globale, veniamo a conoscenza continuamente di ciò che avviene nella altre parti del pianeta e quindi non possiamo ignorarlo, dobbiamo sentircene responsabili. Tuttavia quello che noi veniamo a conoscere è selezionato non secondo nostre scelte, ma secondo ciò che taluni decidono di farci conoscere. E magari quando non fa più notizia, queste informazioni si spengono, anche se i problemi restano. Ciò significa che siamo, sì, globali, ma non siamo un “villaggio”: in un villaggio ci si guarda negli occhi, ci si conosce, si condividono le gioie e le pene di tutti. In definitiva, la globalizzazione deve essere per l’uomo.
A questo punto si impone un’etica per disciplinare la globalizzazione. A questo proposito la voce della Chiesa Cattolica si è fatta sentire più volte nel corso degli anni. Nell’enciclica Populorum Progressio di Paolo VI ad esempio si dice, in riferimento alla visione cristiana dello sviluppo, che “lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo”. E poi: “se il perseguimento dello sviluppo richiede uno sviluppo sempre più grande di tecnici, esige ancor di più degli uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca di un umanesimo nuovo, che permetta all’uomo moderno di ritrovare se stesso, assumendo i valori superiori d’amore, d’amicizia, di preghiera e di contemplazione. In tal modo potrà compiersi in pienezza il vero sviluppo, che è il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane”.
Bellissima è l’elencazione di tutte le situazioni meno umane e di quelle più umane:
“Meno umane: le carenze materiali di coloro che sono privati del minimo vitale e le carenze morali di coloro che sono mutilati dall’egoismo. Meno umane: le strutture oppressive, sia che provengano dagli abusi del possesso che da quelli del potere, dallo sfruttamento dei lavoratori che dall’ingiustizia delle transazioni. Più umane: l’ascesa dalla miseria verso il possesso del necessario, la vittoria sui flagelli sociali, l’ampliamento delle conoscenze, l’acquisizione della cultura. Più umane altresì: l’accresciuta considerazione della dignità degli altri, l’orientarsi verso lo spirito di povertà, la cooperazione al bene comune, la volontà di pace. Più umane, ancora: il riconoscimento da parte dell’uomo dei valori supremi, e di Dio che ne è la sorgente e il termine. Più umane infine e soprattutto: la fede, dono di Dio accolto dalla buona volontà dell’uomo, e l’unità nella carità del Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini.”
Nel parlare della proprietà, Paolo VI cita S. Ambrogio, che afferma: “non è del tuo avere che tu fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché quel che è dato in comune per l’uso di tutti è ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti e non solamente ai ricchi.”
E l’ultimo appello della Populorum Progressio è: “Voi tutti che avete inteso l’appello dei popoli sofferenti, voi tutti che lavorate per rispondervi, voi siete gli apostoli del buono e vero sviluppo, che non è la ricchezza egoista e amata per se stessa, ma l’economia al servizio dell’uomo, il pane quotidiano distribuito a tutti, come sorgente di fraternità e segno della Provvidenza.”
Infine arriviamo ai giorni nostri con Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium dice parole molto forti: chiaramente l’iniquità è la radice dei mali sociali. Parla dell’economia che uccide: no a un’economia dell’esclusione e della iniquità, no alla nuova idolatria del denaro, no a un denaro che governa invece di servire, no all’iniquità che genera violenza. Prego il Signore, dice, che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri. E’ indispensabile, che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto, continua, che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra l’economia e il bene comune sociale.
Vorrei concludere con una riflessione su Teilhard de Chardin, che forse possiamo considerare un profeta di una nuova globalizzazione. Profeta, perché le considerazioni di Teilhard de Chardin risalgono agli anni ’50, quando non si parlava ancora dei problemi della globalizzazione né tanto meno di nuova globalizzazione.
Per Teilhard de Chardin una vera globalizzazione deve seguire il progetto dell’Universo, nel quale Dio e l’Uomo sono contemporaneamente attori e protagonisti, per condurre tutta la storia del mondo ad un preciso sbocco. Per fare ciò occorre un processo educativo degli uomini che abbia il suo fondamento sulla scienza evolutiva e sulla Fede. Questa è l’unica strada per salvare l’umanità e condurla al Fine Ultra Umano a cui è stata destinata. Teilhard de Chardin non prevedeva che un Papa, Giovanni Paolo II, nel 2004 avrebbe detto che la fede e la scienza sono come due ali del sapere.
La globalizzazione inaugura una nuova era umana, che Teilhard de Chardin paragona ad una via Crucis perché richiede rapidi adattamenti e questo produce incertezze e paure. Ricordiamoci che stava parlando nell’immediato dopoguerra, e pure in questo contesto afferma che, malgrado tanti odi scatenati durante i sei anni di guerra mondiale, il blocco umano non si è disgregato. Più ci respingiamo, più ci compenetriamo. Teilhard è ottimista e non ha dubbio che la terra è in via di unificazione. E ricordiamo che per questo pensatore la vera Unione differenzia, non fonde le persone.
Teilhard de Chardin pensa ad un neo-ecumenismo globale, che faccia prendere coscienza a tutti gli uomini di essere ospiti e pellegrini di questa terra, di abitare in una casa comune. E se vogliamo vivere in pace, dobbiamo sapere stare insieme, in una casa (dalla natura vegetale, animale, tecnologica) che appartiene a tutti e nessuno può appropriarsene cacciando fuori gli altri. Teilhard aspira ad un gruppo di governo globale, che rappresenti la diversità di tutti i popoli, applicando il principio di sussidiarietà, per la tutela di tutti i popoli, il cui compito sia soprattutto quello di educare le coscienze a costruire la pace e il vero progresso. Oggi, in un contesto di delegittimazione e svuotamento di significato degli organismi sovranazionali, la visione di Teilhard può essere ancora di stimolo per l’edificazione di una casa comune mondiale, basata non sulle alleanze mutevoli tra poteri ma sull’ideale della progressiva affermazione dei diritti umani.
NOTA
Il presente contributo ha come fonte il libro La globalizzazione della disuguaglianza di François Bourguignon per la parte più propriamente economica. Per come le disuguaglianze interpellano la nostra fede, ci si è basati sull’enciclica Populorum progressio di Paolo VI, su una raccolta di interventi del Cardinale Tettamanzi, sulla Evangelii Gaudium. Per la visione di Teilhard de Chardin come profeta di una nuova globalizzazione è stato d’ispirazione il libro di Vincenzo D’Ascenzi: Teilhard de Chardin a fronte della globalizzazione.












 In collaborazione con il Servizio nazionale della CEI per il progetto culturale e sostenuto con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica
In collaborazione con il Servizio nazionale della CEI per il progetto culturale e sostenuto con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica