Alcune ragioni della crisi d'identità dell'uomo contemporaneo
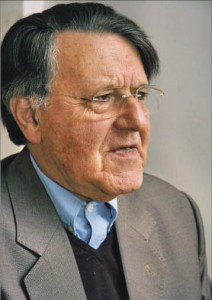 Si parla spesso della «perdita d'identità» di cui soffre l'uomo del nostro tempo e si dà a questa espressione il significato di una perdita di orientamento, di una crisi profonda che ha colpito quadri di riferimento, costellazioni di valori in seno a cui gli uomini erano abituati a collocarsi e a conferire un senso alla propria esistenza. Tutto questo e vero ma il senso ancor più radicale di questa perdita di identità consiste nella difficolta di rispondere alla domanda: «Chi sono?», o più in generale: «Che cos'è l'uomo?». Si tratta di una questione eterna, alla quale già faceva riferimento l'imperativo nel quale l'antichità classica inscriveva l'essenza della saggezza: «Conosci te stesso» (un invito che non era formulato da un saggio qualunque, ma si riteneva provenire dalla divinità, in quanto veniva attribuito all’oracolo di Apollo a Delfi).
Si parla spesso della «perdita d'identità» di cui soffre l'uomo del nostro tempo e si dà a questa espressione il significato di una perdita di orientamento, di una crisi profonda che ha colpito quadri di riferimento, costellazioni di valori in seno a cui gli uomini erano abituati a collocarsi e a conferire un senso alla propria esistenza. Tutto questo e vero ma il senso ancor più radicale di questa perdita di identità consiste nella difficolta di rispondere alla domanda: «Chi sono?», o più in generale: «Che cos'è l'uomo?». Si tratta di una questione eterna, alla quale già faceva riferimento l'imperativo nel quale l'antichità classica inscriveva l'essenza della saggezza: «Conosci te stesso» (un invito che non era formulato da un saggio qualunque, ma si riteneva provenire dalla divinità, in quanto veniva attribuito all’oracolo di Apollo a Delfi).
L’aspetto paradossale di questo invito è dato dal fatto che, apparentemente, la conoscenza di sé è un compito facile, non essendovi diaframmi che si interpongono fra il soggetto che conosce e l'oggetto di questa conoscenza. Tuttavia, questa apparente facilità si trasforma in un’enorme difficoltà quando si consideri invece la conoscenza come un'operazione che esige un’alterità, una presa di distanza tra soggetto e oggetto. A partire da quel momento, la «oggettivizzazione» di sé si presenta come un’impresa disperata, e ci si sente spinti a ricercare dei mezzi indiretti (vale a dire delle «fonti di conoscenza») per realizzarla.
L’inevitabile conseguenza è che la risposta alla fondamentale domanda in oggetto dipenderà fatalmente dalla natura dei mezzi utilizzati o accettati, e che l’identità dell’uomo sarà ricostruita secondo le caratteristiche che questi mezzi sono in grado di trattare, o che queste fonti di conoscenza sono in grado di offrirci. Nel corso dei secoli, l'Occidente ha ritrovato tali mezzi nella filosofia e nella religione, e tali fonti di conoscenza nella metafisica e nella rivelazione. Con l'età moderna, un nuovo strumento conoscitivo comparve all'orizzonte: la scienza naturale, che non utilizza più né la metafisica né la rivelazione. Lo spazio concettuale nel quale essa racchiude tutto ciò che può conoscere si riduce alla materia e al movimento (quest'ultimo governato da «forze» che lo determinano agendo «dall'esterno» sui corpi materiali).
Gli spiriti più attenti avvertirono subito il rischio che la dilatazione incontrollata di questa nuova fonte di conoscenza comportava, e si preoccuparono immediatamente di «salvare l'uomo». La soluzione adottata fu una concezione dualista dell'essere umano, concezione inaugurata da Cartesio, ma accettata in diverse forme da parecchi pensatori, fino a Kant. Tuttavia, una tale soluzione già presupponeva la perdita d'identità dell'uomo (perché l'identità implica una unità nella quale possano ritrovarsi tutte le differenze).
Di fronte a questo naufragio, l'idealismo cosiddetto «trascendentale» ha avuto il merito eccezionale di demolire la «trascendenza» cognitiva del reale rispetto al pensiero (che aveva imprigionato la filosofia moderna); tuttavia ha finito per eliminare ogni forma di trascendenza, e ha trasformato il Pensiero in un assoluto immanente. L'uomo si trovava così «divinizzato», ma una volta di più non poteva riscoprire la propria identità in questa iperbole, perché essa non riusciva a rendere conto della sua finitezza, così come della sua individualità e della sua libertà personale.
Mentre certe filosofie dell'immanenza esaltavano fino a renderla praticamente inconsistente la dimensione spirituale dell'uomo, le scienze naturali progredivano, e a poco a poco svuotavano questa dimensione, riducendola a una sorta di inutile fantasia. Infatti, la scienza naturale si era vista assegnare come appartenente al proprio dominio di competenza il corpo dell'uomo, con la riserva mentale che, in ogni modo, un uomo autentico rimaneva intatto nella cittadella della sua soggettività, città della alla quale la scienza naturale non aveva accesso e che restava nella sfera di competenza della metafisica e della teologia. Ma, sfortunatamente, questo ragionamento finiva in effetti per legittimare il punto di vista inverso: nessun lume, nessun principio relativo al dominio dello spirituale, del metafisico, del trascendente era più considerato necessario per spiegare la struttura e il funzionamento del corpo dell'uomo. Ecco perché si osserverà presto, nell'interpretazione dell'uomo, un fenomeno analogo a quello che si era prodotto nell'interpretazione del mondo fisico: proprio come Dio era divenuto una bocca inutile in cosmologia (ci si ricorderà la famosa risposta di Laplace a Napoleone: «Non ho avuto bisogno di questa ipotesi»), così l'anima spirituale diveniva una bocca inutile (un'ipotesi superflua) nella comprensione del corpo umano.
Avremmo potuto nondimeno attenderci che, estendendo progressivamente le indagini sul lato o «componente» materiale dell'uomo, si arrivasse a toccare certi limiti che obbligassero a fare appello all'altra dimensione, all'altra «componente». Ma una tale eventualità era resa quasi impossibile per tre ragioni fondamentali: il fatto di aver interpretato la dualità corpo-spirito come una giustapposizione di due sostanze, il fatto di avere adottato il metodo analitico come unico metodo di comprensione e spiegazione razionale, l'adozione della macchina come modello interpretativo ed esplicativo di portata generale.
La macchina come modello di intelligibilità
Particolarmente rilevante è risultato il ruolo dell'ultimo di questi tre fattori, conseguenza del sorgere della tecnologia, cioè di quella novità nel campo della pura e semplice tecnica che si produce con lo sviluppo della scienza moderna. Mentre lo strumento tecnico e in generale il frutto di una scoperta più o meno fortuita, che si perfeziona e affina nel corso del tempo per accumulazione di esperienze pratiche, la macchina ha questo di peculiare: essa è inventata, ossia progettata in anticipo, e si sa come sarà strutturata, come funzionerà e perché funzionerà in quel modo prima di averla concretamente realizzata.
Tutto ciò equivale a dire che in una macchina non v’è nulla di misterioso, che tutto è, in linea di principio chiaro e distinto, perché essa risulta dalla composizione di parti la cui struttura è perfettamente nota, disposte secondo un ordine ben noto (dato che siamo noi stessi ad averlo progettato) e funzionante secondo leggi fisiche che conosciamo e che abbiamo coscientemente applicato. Si comprende allora facilmente il ruolo epistemico che assume la macchina: essa non è più soltanto uno strumento la cui efficacia supera largamente quella dei prodotti o dei processi naturali, ma è anche un formidabile modello concettuale. Quando saremo riusciti a interpretare un qualunque sistema naturale come una certa macchina più o meno complessa, strutturata e funzionante secondo le leggi di una certa scienza che dominiamo, avremo l'impressione di averlo compreso e spiegato in modo completo; esso non avrà più misteri per noi. Questa condizione di intelligibilità sembra dispensarci dall'obbligo di arrestarci là dove non siamo più in grado di osservare.
Impossibile negare il fascino di un tale modello concettuale, la cui applicazione all'uomo divenne irresistibile una volta che il quadro del dualismo cartesiano si fu imposto. E Cartesio stesso ci ha in effetti lasciato uno dei primi esempi di teoria dell'uomo-macchina, inaugurando una serie ininterrotta di visioni analoghe, basate sui tipi di macchina che nuove scienze permettevano di immaginare a mano a mano che esse giungevano a imporsi nella cultura occidentale (macchina chimica, termodinamica, elettromagnetica, cibernetica).
L'eliminazione della categoria di finalità
Una seria difficoltà ostacolava l'adozione della macchina come modello dei sistemi naturali: una macchina implica sempre un'organizzazione, un piano, un progetto finalizzato, e questa finalità esiste semplicemente perché esprime l'intenzione di qualcuno che ha progettato e costruito la macchina. Quest'ultima resterebbe dunque «misteriosa», se non si tenesse conto di questa circostanza fondamentale. Utilizzando una terminologia aristotelica, si deve dire che la macchina è una sostanza la cui «orma» (vale a dire il principia essenziale che determina a un tempo la sua struttura organizzata e il suo funzionamento) è stata concepita prima della sua realizzazione e l’ha guidata.
Per lungo tempo, tale difficoltà non fu presa sul serio, poiché la nozione di finalità era stata categoricamente esclusa dalla scienza naturale moderna, per due ragioni fondamentali: in primo luogo perché essa sembrava lasciare la porta aperta all'irruzione di un'Intelligenza trascendente nella spiegazione della natura (il che era in contrasto con lo spirito secolarizzato della modernità); in secondo luogo perché, se ci si fosse limitati (come faceva Aristotele) a iscrivere la finalità nella forma sostanziale degli esseri naturali, si sarebbe dovuto far posto, nella scienza, alla conoscenza delle essenze, mentre, a partire da Galileo, questa stessa scienza dichiarava di volersi limitare al semplice studio dei fenomeni, rinunciando all’indagine delle cause e delle ragioni ultime che la filosofia tradizionale individua nelle essenze.
La tecnologia e la portata ontologica delle scienze
La tecnologia ricopre un ruolo particolarmente decisivo, in quanto offre alla scienza (di cui è l'applicazione concreta) un argomento molto forte per affermare le sue pretese ontologiche (e anche per consolidare l'idea che l'unica forma di finalità che si può concretamente affermare e quella degli artefatti tecnologici, i quali sono per l'appunto voluti dall'uomo). Se ci si limita a considerare la scienza pura, infatti, si deve affermare che essa si propone di descrivere, comprendere, spiegare la realtà e, anche in presenza dei suoi indiscutibili successi, si può sempre sostenere che essa può solo offrirci un inquadramento logicamente soddisfacente dei fenomeni, il quale non possiede peraltro alcuna necessità intrinseca e può essere modificato in modo più o meno convenzionale: è questo il senso delle numerose epistemologie antirealiste attuali. Tuttavia, la scienza moderna non si limita a conoscere il mondo ma, grazie alla tecnologia che applica le sue conoscenze, essa è capace di modificare il mondo e anche di creare nuove realtà. Il mondo tecnologico è un gigantesco sistema di «sostanze» che non esistevano prima che l'uomo le avesse prodotte, e sarebbe semplicemente ridicolo dire che questi artefatti tecnologici sono pure fenomeni. Parrebbe dunque legittimo affermare che la sola realtà autentica è quella che la scienza studia, perché è la scienza che ci permette di intervenire su di essa e di estenderne considerevolmente la ricchezza e i confini.
Da questo punto di vista, la tecnologia oggi non si limita più a fornire, grazie alle macchine, dei modelli concettuali per comprenderne i sistemi naturali, ma permette di costruire delle macchine materiali concrete che si comportano come i sistemi studiati. Evidentemente, si ha il diritto di osservare che queste macchine restano pur sempre dei «modelli» artificiali, rispetto ai sistemi naturali, ma nondimeno esse sono qualcosa di più che puri modelli «ideali»; esse sono, per così dire, modelli «ontologici» e la loro efficacia sembra giustificare la tesi che i sistemi naturali non hanno uno statuto ontologico diverso, e che non c’è bisogno di ricorrere ad altri principi ontologici per spiegarli.
Se si applica questa strategia alla modellizzazione di sistemi naturali che (come l’uomo) sono capaci di attività cosiddette mentali (che vanno dalla percezione alla memoria, al ragionamento deduttivo, all’astrazione, alla comunicazione verbale), si cominciano a costruire macchine in grado di realizzare concretamente le stesse funzioni degli esseri umani e, grazie a questa scappatoia, ci si crede autorizzati ad affermare che tali funzioni non richiedono l’esistenza di una sostanza non materiale (quale lo spirito) per essere comprese e spiegate. In questo modo, lo spirito si riduce a un epifenomeno della materia: la materia, quando abbia raggiunto il livello di complessità necessario (grazie alle dinamiche del caso e della necessità, oggi divenute abbastanza chiare), diventa capace di pensare.
Critica del modello dell'uomo-macchina
L'uomo trasferisce integralmente la propria natura nelle azioni che compie: quindi la sua dimensione «intenzionale» è sempre presente in esse. Vi sono tuttavia azioni (che la tradizione classica chiamava «immanenti») che non danno luogo a modifiche del mondo esterno, ma restano per così dire «nel soggetto» (come pensare, vedere, ascoltare, desiderare, volere, credere ecc.), mentre altre (dette «transitive») mettono capo a una modifica del mondo esterno (producono risultati osservabili). Noi chiameremo «operazioni» le azioni di questo secondo tipo. Le operazioni possono essere adeguatamente definite indicando lo «stato del mondo» prima e dopo la loro esecuzione, mentre il modo in cui la trasformazione si compie è indifferente. Ora accade che molte attività che l’uomo esegue affidandosi alla sua intenzionalità possano essere analizzate e tradotte in operazioni: per esempio, il ragionamento deduttivo (basato sulla nozione intuitiva e intenzionale di «conseguenza logica») fu analizzato e tradotto in un insieme di regale formali già da Aristotele, e tali regole non sono che prescrizioni relative alla manipolazione di segni materiali (che sono, appunto, operazioni). Non c'è allora da stupirsi che si possa costruire una macchina capace di manipolare segni materiali secondo le stesse regole, eseguendo così le operazioni della deduzione formale. Ma sarebbe arbitrario affermare che questa macchina ha dimostrato qualcosa, perché essa non dispone di quell'intenzionalità che le permetterebbe di rendersi conto che essa ha accertato la permanenza della verità delle premesse nelle conclusioni. È l'utilizzatore della macchina che, interpretando i segni e le regole operative, potrà sostenere di avere ottenuto una dimostrazione grazie allo strumento materiale utilizzato.
L'esempio qui presentato ci fornisce la sommaria indicazione di un'osservazione critica generale che riguarda le modellizzazioni delle attività «mentali» operate in seno all'intelligenza artificiale, quando si attribuisca a esse la pretesa di dimostrare la natura materiale del pensiero. Esse non possono che imitare certe operazioni a cui mette capo l'esercizio del pensiero, ma questa non implica in alcun modo che il pensiero agisca come una macchina (ogni operazione è largamente indipendente dal modo in cui viene effettuata e, a maggior ragione, dalla natura dell'agente). Beninteso, l'interesse pratico e teorico di queste modellizzazioni resta immutato: in particolare, quando si basano su una «simulazione» effettiva di processi neurofisiologici o psicologici, esse ci forniscono una notevole quantità di informazioni sulle condizioni materiali necessarie per l’esercizio di queste funzioni intellettuali, ma non hanno titolo per sostituirsi alla dimensione tipicamente umana dell’intenzionalità. Ecco una delle ragioni per cui l’uomo contemporaneo sente di aver perduto la propria identità quando viene invitato a considerare se stesso come una «macchina pensante».
La dimensione morale nell'uomo
Passiamo ora a un altro ordine di evidenze fenomenologiche che l'essere umano rinviene in seno alla sua interiorità: le evidenze morali. Con ciò, non vogliamo far riferimento al fatto che certe azioni particolari ci appaiono immediatamente come buone in sé (come, per esempio, aiutare il proprio prossimo) e altre cattive (come, per esempio, uccidere), ma al fatto più generale che ogni essere umano è capace di giudizio morale, vale a dire di un tipo di giudizio secondo il quale esiste un dovere di fare il bene e di evitare il male. Ora, la nozione di dover essere e dover fare è totalmente inapplicabile al mondo della natura e, di conseguenza, non figura tra i concerti e i principi delle scienze e della tecnologia. Ogni sistema naturale e artificiale si comporta secondo le «regole costitutive» che determinano la sua struttura e il suo funzionamento, regole da cui non può deviare. Si capisce quindi come ogni interpretazione che riduca l'uomo a una macchina (sia pure molto complessa, risultante dalla composizione di diverse macchine) turbi profondamente la sua identità, in quanta svuota di senso la sua dimensione morale. Se l'uomo non fosse altro che il risultato di certi meccanismi (di tipo interno, come quelli legati alla sua struttura, o di tipo esterno, come quelli che risultano dall'azione dell'ambiente naturale o sociale), le sue azioni si ridurrebbero in realtà a puri comportamenti del tutto condizionati e peri quali non c'è alcuna possibilità di domandarsi se siano o no conformi a ciò che dovrebbero essere.
Quanto detto equivale a riconoscere che una pura e semplice lettura tecnoscientifica dell'uomo lo defrauda di quell'aspetto essenziale della sua identità che è rappresentato dalla coscienza della sua libertà, senza la quale il senso proprio della moralità si annulla, così come spariscono il senso di ogni progetto di vita, la ragion d'essere della responsabilità e qualsiasi forma di creatività. Questa libertà radicale consiste nella libertà di volere o libertà di scelta (detta anche «libero arbitrio»), ed essa non è incompatibile con limitazioni anche molto forti della libertà d'azione. Da sempre l'uomo è stato cosciente del fatto che la sua libertà d'azione è subordinata a parecchie limitazioni, e le scienze (naturali e «umane» hanno portato alla luce una serie di «determinismi» e condizionamenti che accerchiano le nostre azioni. Sfortunatamente, il pensiero moderno ha radicalmente identificato la libertà con la libertà d’azione, cosicché ogni progresso scientifico (necessariamente consistente nella scoperta di qualche nuovo «meccanismo» capace di determinare i processi di questa o quest'altro aspetto della realtà) sembra ridurre sempre più lo spazio della libertà (di azione), sino a fare della stessa nozione di libertà una pia illusione. L'unico aspetto dell'azione libera suscettibile di essere afferrato «dall'esterno» è il fatto che essa è imprevedibile. Si penserà allora di poter «simulare» tali azioni mediante macchine dotate di un dispositivo «aleatorio» (del tipo di una roulette) e, nel caso di modellizzazioni artificiali della coscienza umana, si dirà, per esempio, che tali disposizioni imprevedibili sono l'effetto di fenomeni aleatori che si svolgono a livello subatomico (come i «salti quantici» e altri effetti fisici che cadono sotto il principio di indeterminazione di Heisenberg). Ora, ogni uomo è ben conscio che scegliere liberamente è altra cosa che comportarsi a caso; quindi, se egli accetta di riconoscersi nell'immagine tecnoscientifica dell'uomo, non potrà che restare sconcertato davanti a questa incongruenza.
Uno dei paradossi più rilevanti della cultura moderna è il seguente: proprio mentre opera una riduzione progressiva dell'uomo allo statuto di un essere naturale qualunque, la cultura moderna si dedica a celebrare la dignità dell'uomo e a proclamare solennemente un numero crescente di diritti umani. L'età contemporanea ha già raggiunto una «terza generazione» nella determinazione di tali diritti, e questi costituiscono ormai una sorta di base comune della coscienza morale attuale, anche a livello di etica pubblica. Come si può conciliare questo atteggiamento morale con l'idea che l'uomo è una macchina? Che senso ha affermare che si deve rispettare una macchina? L’atteggiamento razionale verso una macchina non è, appunto, quello di sfruttarla al massimo? Ecco un altro aspetto della perdita di identità provocata da una visione puramente tecnoscientifica dell’uomo: essa recide alla radice le ragioni per affermare la dignità dell’uomo e i suoi diritti fondamentali.
Come sfuggire ai rischi della tecnoscienza?
Nel corso degli ultimi decenni si è manifestata una forte inquietudine riguardo alla tecnoscienza perché, dopo che per un periodo molto lungo si era identificato il suo sviluppo con il progresso dell'umanità, si è cominciato a constatare che questo sviluppo può benissimo produrre danni, fino a mettere in pericolo la sopravvivenza dell'umanità. La tecnoscienza può dunque provocare del male e anche se, in un primo tempo, questo male è stato configurato sotto la forma abbastanza rudimentale del pericolo fisico, le riflessioni si sono presto orientate nella direzione di una vera e propria discussione etica, nella quale si è posto il delicato problema di una regolamentazione, e anche di una limitazione, della tecnoscienza. Ma a che cosa appellarsi per risolvere questo problema? A questo riguardo ci si ritrova disorientati, per il semplice fatto di aver accettato l'idea che la nozione di finalità debba scomparire dallo spazio concettuale della «razionalita», quale la tecnoscienza ce l'ha imposta.
Per meglio comprendere la questione, è utile considerare la posizione favorevole nella quale si trovava la visione tradizionale di tipo metafisico (e teologico), che vedeva una finalità nella natura, nel duplice senso che ogni essere naturale porta nella sua stessa essenza il disegno della propria finalità individuale, e che queste diverse finalità sono armonizzate in una finalità globale (l'«ordine naturale»). Anche l'uomo era compreso in questa prospettiva: egli aveva la sua finalità propria (che seguiva da tutte le sue caratteristiche essenziali) e doveva iscrivere le sue azioni nell'«ordine morale» (che a sua volta si compenetrava con l'ordine naturale).
Al contrario, non esiste nessuna finalità precisa nella tecnoscienza, perché il suo progresso dipende dalle conoscenze e dai metodi già acquisiti: essa avanza sotto l’impulso di situazioni cognitive e di problemi che sono a «monte di essa».
Per ciò che concerne, in particolare, la tecnica, è facile riconoscere che ogni novità tecnica è in misura minima realizzata secondo un'intenzione (e dunque una finalità) immediata e a breve termine, mentre dipende altresì (in più larga misura) dalle realizzazioni già acquisite e dai problemi e le attese che esse suscitano. In ogni caso, anche se si volesse indicare nella volontà umana la fonte dei fini della tecnoscienza, tale volontà non arriverebbe a istituire una finalità globale in termini di puri criteri tecnoscientifici. Essa infatti, dal punto di vista di essere la scaturigine della tecnica nel senso più primordiale e indeterminato, è anche considerata nei suoi aspetti più affascinanti e «romantici», è una volontà creatrice che, come una fonte impetuosa, fa scaturire un torrente il cui corso le sfugge e non le interessa più di tanto.
Di fronte alle difficoltà nell'affrontare il problema di dirigere e limitare il corso della tecnoscienza, è oggi abbastanza diffusa una risposta illusoria a tale questione: bisogna «ritornare alla natura», arrestare la crescita dell'artificiale e tornare al naturale o, quantomeno, subordinare l'artificiale al naturale. Questa risposta è inadeguata per una serie di ragioni. In primo luogo, l'ordine naturale non ha più ai nostri occhi quel valore metafisico e teologico che un tempo poteva farne la misura delle azioni umane. In secondo luogo, l'artificiale non è che la manifestazione più tipica della natura umana, caratterizzata dal fatto che l'uomo assicura la sua sopravvivenza e il suo progresso adattando la natura alle sue esigenze, invece di adattarsi a essa. In terzo luogo, è grazie all'artificiale che l'uomo ha potuto migliorare le proprie condizioni di vita, anche sotto il profilo della propria esistenza biologica e «naturale» (sopravvivenza, salute, protezione contro le forze naturali avverse ecc.). Infine, la natura stessa è oggi interpretata, compresa e spiegata secondo i metodi e i modelli della tecnoscienza, cosicché non si saprebbe immaginare a quale Natura falsamente primordiale si dovrebbe «ritornare».
Il mito di Protagora
Una risposta più soddisfacente ci è offerta sulla traccia di un mito che esprime l'antica saggezza di fronte a quella «creatività» che costituisce il privilegio dell'uomo: il mito narrato da Protagora nel dialogo di Platone he porta questo stesso titolo. Quando gli dei decisero che era giunto il tempo di popolare la terra di esseri viventi, affidarono a Prometeo ed Epimeteo il compito di forgiarli e dotarli di qualità adeguate. Epimeteo si mise al lavoro, mentre Prometeo si riservò il compito di sovrintendere il risultato. Dopo aver saggiamente distribuito fra le diverse specie animali le dotazioni che avrebbero loro consentito di sopravvivere e riprodursi in un ordine armonioso, Epimeteo si accorse, al momento di forgiare l'uomo, di aver già esaurito l'intera riserva delle qualità naturali. Si contentò dunque di produrre un essere vivente debole, nudo, sprovvisto di tutto e inferiore a tutti gli altri animali. Per rimediare a questo risultato disastroso, Prometeo rubò a Efesto il fuoco e le arti che gli sono apparentate (vale a dire i principi della tecnica) e ad Atena le arti dell'intelletto (vale a dire i principi della scienza). Queste qualità furono divise in diversa misura fra gli uomini ed essi, utilizzandole, poterono assicurare la propria superiorità sugli animali, cominciarono a realizzare un gran numero di prodotti artificiali e a fondare delle città. Tuttavia, essi si rivelarono incapaci di vivere in comunità e cominciarono a uccidersi l'un l'altro, a disperdersi e a morire. Fu allora che Zeus, preoccupato per la sorte degli uomini, incaricò Hermes di portare a costoro le virtù politiche della giustizia e del pudore; ma queste furono concesse a ogni uomo individualmente e fu grazie a esse che gli uomini furono capaci di realizzare una vita armoniosa nelle loro città.
Attraverso questo mito (e nelle discussioni che lo seguono nel dialogo) si coglie già, nel colpo d'occhio di un genio filosofico come Platone, tutto il problema della tecnoscienza. Scienza e tecnica sono il segno della superiorità dell'uomo sulla natura, esse si sviluppano grazie all'opera di individui particolarmente dotati, ma conducono a un risultato funesto se non sono guidate da qualcosa che non è la conformità alla natura, ma piuttosto un'altra qualità unicamente umana, quella della moralità. Questa produce un effetto globale positivo, in quanto è una caratteristica posseduta da ogni uomo individualmente.
Dominare la tecnoscienza con la tecnoscienza?
Il mito di Protagora ci indica la debolezza di un’altra credenza illusoria (anch’essa assai diffusa), circa la possibilità di regolare «globalmente» la tecnoscienza; si afferma spesso che, a mano a mano che le nostre conoscenze aumenteranno, arriveremo a «scoprire» i mezzi per controllare la tecnoscienza (questa sarebbe in grado di tenere sotto controllo i propri stessi pericoli).
Tale convinzione poggia su un modo ingenuo di concepire il progresso delle conoscenze: si immagina la sfera dell'ignoto come una sorta di terreno vasto ma limitato, che può essere esplorato fino a esaurirne tutta l'estensione. Ma c'è un'altra immagine molto più adatta a rappresentare il progresso conoscitivo: il contenuto del nostro sapere è come la superficie di un cerchio, la cui circonferenza rappresenta il limite, la frontiera di contatto con l'ignoto. Man mano che la superficie del cerchio aumenta, aumenta anche la lunghezza della circonferenza, e dunque «la frontiera dell'ignoto». D'altronde, è ben noto che dalla soluzione di ogni problema scientifico emergono nuovi problemi scientifici (e lo stesso vale per la tecnica). Ciò non significa che un certo problema non abbia avuto soluzione, ma che vi sono altri problemi che vengono sollevati da quella soluzione stessa. Non è dunque attraverso un tale percorso che si potrà pervenire a una soluzione «globale».
Questa fuga in avanti non serve dunque a nulla, per la buona ragione che si tratta di una fuga verso l'esterno. Pertanto, l'indicazione corretta non è quella di un percorso a ritroso, ma piuttosto quella di un recupero di ciò che sta all'interno. Per riprendere la nostra immagine, non è con la sterile pretesa di tenersi aggiornata dilatando la circonferenza (vero e proprio lavoro di Sisifo faticoso e frustrante) che l'umanità potrà risolvere questo problema decisivo, ma solo valorizzando il centro del cerchio, vale a dire l'interiorità dell'uomo che è, in fin dei conti, la fonte di ogni scienza e di ogni tecnica, e che trova nella coscienza morale elargita a ogni individuo i criteri per dirigere le proprie azioni, senza attenderli da impossibili «conoscenze» più avanzate che (senza tali orientazioni) non sapremmo neppure come utilizzare bene.
La tecnica fa appello all’etica
Qualcosa di abbastanza sorprendente, dunque, si è venuto realizzando negli ultimi decenni: mentre un’attenuazione del senso morale e una crisi dei valori e dei costumi tradizionali sembravano oggettivamente emergere in seno alle società contemporanee, un forte e improvviso risveglio della sensibilità etica emergeva dal mondo della tecnoscienza. Proprio come nel mito di Protagora, gli uomini, dopo aver coltivato l’illusione che il puro sapere «oggettivo», rigoroso imparziale e impersonale – che caratterizza la razionalità scientifica – avrebbe fornito loro le indicazioni corrette su ciò che si deve fare, e che il sapere efficace, altrettanto rigoroso e impersonale – caratterizzato dalla razionalità tecnologica – avrebbe loro anche indicato i mezzi più idonei per realizzare le loro finalità si sono resi conto che, in realtà, la combinazione di questi due saperi stava dando luogo a un processo cieco di dilatazione incontrollata e senza scopi, i cui effetti a scadenza non troppo lunga potrebbero essere l'annientamento della stessa umanità o, perlomeno, un grave degrado delle sue condizioni di sopravvivenza. Si sono così sentite riecheggiare, nelle discussioni sul controllo della tecnoscienza, parole che sembravano obsolete nei discorsi della nostra epoca, come quelle di responsabilità, dovere, rispetto della dignità e dei diritti delle persone presenti e future. Queste parole traducono istanze che non dipendono dal grado delle conoscenze scientifiche o delle realizzazioni tecnologiche, ma che ogni essere umano riporta a una sfera completamente diversa e ben precisa, quella del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, del dovere ossia alla sfera morale.
In fondo l’uomo contemporaneo, dopo secoli nei quali si era abituato a sentirsi frustrato di fronte alle molte cose che non era capace di fare, si è visto di colpo (grazie alla tecnoscienza che ha aperto in modo smisurato le sue capacità di realizzazione) nella situazione di comprendere che ci sono molte cose ormai che egli è capace di fare, ma che non deve fare e che, anzi, il vero problema dell'umanità, al giorno d'oggi, non è più quello di accrescere le proprie possibilità di azione, bensì quello di operare delle scelte corrette. Il che è come dire che sta emergendo con forza crescente la priorità della dimensione etica su quella tecnico-pragmatica, priorità che, peraltro, non si è imposta in base a riflessioni filosofiche bensì come una conseguenza storica degli stessi sviluppi della tecnoscienza.
È significativo che, come nel mito di Protagora, questa coscienza etica abbia il valore e la funzione di una condizione per la sopravvivenza e il fiorire della vita associata. Fin tanto che gli uomini - narra il mito - vivevano usufruendo dei doni delle scienze e delle tecniche, e del loro fiorire creativo ma anarchico, essi seppero dar luogo a «città» (cioè a forme di vita associata), ma non a una convivenza armoniosa e sicura dentro di queste. Per questo fu loro necessario il dono divino delle virtù «politiche». Oggi la scienza e la tecnica hanno consentito agli uomini di realizzare una grande città, unificando a livello planetario le forme di vita del genere umano, e ormai questa umanità si presenta sempre più come una comunità di storia e di destino. Ma quale sarà tale destino? Sapranno gli uomini, con le loro opere, realizzare una convivenza pacifica, dignitosa e prospera, oppure produrranno la loro rovina? Solo una coscienza e un impegno di virtù civili sarà in grado di assicurare all'umanità un avvenire di progresso.
La via etica al recupero dell'identità dell'uomo
Quella che lo sviluppo della tecnoscienza ci ha indotto a riscoprire e in sostanza l'esigenza di un'etica pubblica, ossia di quelle virtù che si chiamano civili perché riguardano la convivenza degli esseri umani in comunità. Tuttavia, come si è visto, queste virtù civili si basano su alcune dimensioni individuali della moralità, come (prima fra tutte) la coscienza del bene e del male e, subito dopo, il senso del dovere, il senso della responsabilità e dell'impegno personale. Sono queste caratteristiche che stanno alla base di due atteggiamenti: quello del giudizio morale e quello della scelta, i quali non possono essere che individuali e, nello stesso tempo, marcano con nettezza e con chiarezza di evidenza fenomenologica la differenza del soggetto umano rispetto al mondo delle cose (ivi compreso quello della tecnoscienza) e la sua superiorità rispetto a esso (superiorità implicita nella possibilità di giudicare, e non intaccata da altre forme reali o possibili di dipendenza). E così che l'uomo ritrova se stesso e la propria identità nell'esperienza fondamentale della sua coscienza e responsabilità morale, la quale lo aiuta a comprendere che questo tentacolare mondo della tecnoscienza, dopo tutto, è stato realizzato da lui (e continua a esserlo), che dipende, ontologicamente, dalle sue decisioni, anche se può fortemente determinare le sue condizioni di vita e possibilità d'azione. Pertanto, esso non si sottrae in linea di principio alle sue possibilità di intervento, a condizione che queste siano decise e attuate nelle forme pertinenti, le quali non sono certamente quelle che erano sufficienti a regolare l'azione individuate, tipicamente considerata dall'etica tradizionale.
Non vogliamo comunque addentrarci in questo discorso, che ci condurrebbe troppo lontano. Ci interessa invece accennare, almeno per sommi capi, a un aspetto, già affiorato in precedenza, che ora riemerge con forza proprio sulla scorta della coscienza morale, ossia il fatto che il ritrovamento dell'identità dell'uomo richiede un autentico recupero della sua dimensione di interiorità.
Evandro Agazzi, La tecnoscienza e l'identità dell'uomo contemporaneo, in La tecnica, la vita, i dilemmi dell'azione. Annuario di Filosofia, Mondadori, Milano 1998, pp. 74-89